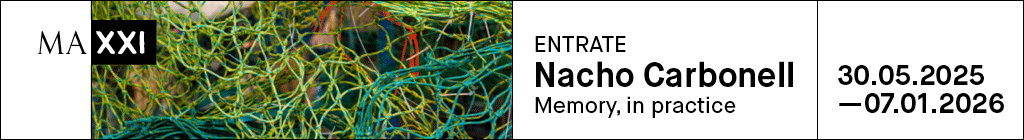Padiglioni Biennale: la Finlandia raddoppia
Ideati a Helsinki sia l’allestimento che stressa la spazialità di Sverre Fehn (Paesi Nordici) che il racconto del piccolo edificio ai Giardini di Alvar ed Elissa Aalto
LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DELLO SPECIALE
Due padiglioni iconici ci accolgono ai Giardini della Biennale e ci consentono di mantenere un filo diretto con le oscillazioni della cultura architettonica e del design dei Paesi Nordici.
Da un lato il grande padiglione in calcestruzzo e vetro realizzato nel 1962 su progetto di Sverre Fehn, la casa comune di Svezia, Norvegia e Finlandia, dall’altro il piccolo padiglione in legno realizzato nel 1956 su progetto di Alvar e Elissa Aalto dove espone la sola Finlandia. Alla 19° Mostra Internazionale di Architettura, curata da Carlo Ratti, la Finlandia gioca un ruolo primario in entrambi e pone al centro della scena proprio i padiglioni.
Corpi nello spazio
“Industry Muscle: Five Scores for Architecture” esplora l’impatto dello spazio sul corpo, sulla società e sull’ambiente. La scelta del nuovo museo di Architettura e Design di Helsinki, a cui è affidata quest’anno la responsabilità del padiglione, è provocatoriamente ai margini dell’architettura o meglio interpreta la volontà di aprire l’architettura e i suoi spazi all’arte performativa.
La curatrice Kaisa Karvinen e l’artista Teo Ala-Ruona forzano lo spazio di quella che definiscono “l’opera canonica del modernismo di Sverre Fehn” con un modello alternativo di pratica architettonica che prende il corpo trans come punto di partenza per esplorare l’ambiente materiale e le questioni ecologiche.
Cinque installazioni (Five Scores) sono lo stage di performance quotidiane a cui tutti i visitatori sono esposti, animate da un team multidisciplinare, l’architetta A.L. Hu, la scenografa e artista Teo Paaer, il sound designer Tuukka Haapakorpi, la dramaturga Even Minn, l’artista visiva Venla Helenius, lo stilista Ervin Latimer, la graphic designer Kiia Beilinson e le performer Kid Kokko, Caroline Suinner e Romeo Roxman Gatt.
Teo Ala-Ruona dichiara che “l’ambiente costruito è in gran parte modellato secondo le norme culturali dominanti. Questo gioca un ruolo cruciale nella messa in scena dei corpi nella vita quotidiana, così come nella creazione del peso ecologico dell’industria edilizia. Con il mio team di collaboratori multidisciplinari, voglio avviare nuove conversazioni esplorando le possibilità di una pratica architettonica in netto contrasto con lo status quo”. Secondo la curatrice questo approccio può aprire “nuove prospettive nel discorso architettonico, in particolare riguardo all’ambiente costruito, al corpo e alla cultura dei combustibili fossili”.
L’esplorazione delle contaminazioni dell’architettura con altri mondi è la strada che il neonato museo di Helsinki – frutto della recente fusione del Museo dell’architettura e Museo del design – sta perseguendo in questi anni di totale ripensamento del proprio ruolo nella società.
Effimero ma duraturo
“Il Padiglione della Finlandia è un’architettura iconica, ma non esisterebbe senza il lavoro e la cura continui di molti durante la sua vita […] Ogni progetto di architettura racconta una storia di intenzioni che si svelano nel viaggio dal primo schizzo all’edificio abitato”, dice Ella Kaira, co-curatrice del Padiglione.
La costruzione del padiglione della Finlandia ai Giardini può essere considerata un tassello significativo dell’affermazione internazionale dell’architettura finlandese negli anni Cinquanta, la seconda età d’oro. Al centro la determinazione di una figura che merita di essere ancora indagata, quella di Maire Gullichsen, artista e mecenate, al vertice della più grande industria del legno del Paese, protagonista della fondazione di Artek insieme a Aino e Alvar Aalto.
L’assenza di uno spazio espositivo per la Finlandia si traduce in una spettacolare successione di eventi guidato da Maire, dal progetto commissionato a Alvar e Elissa al superamento di ogni tipo di ostacolo, dalla fornitura dei materiali al loro trasporto messo a rischio da uno sciopero generale.
Un padiglione in legno – da sempre il materiale identitario del Paese – pensato per essere costruito in pochi giorni, smontabile, un oggetto misurato e rispettoso del contesto, che miracolosamente si rivela al pubblico della Biennale 1956 dopo due sole settimane di montaggio. Quel padiglione è al centro della storia che i curatori della mostra – Eira Kaira e Matti Jänkälä – hanno ricostruito e Merle Karp tradotto in un video con apparato sonoro di Jussi Hertz.
“Il padiglione non è un semplice edificio, è la una narrazione stratificata nel tempo di collaborazione e cura […] frutto di una responsabilità condivisa che trascende l’autorialità e il tempo”, scrive Katarina Siltavuori nella prefazione del libro che accompagna la mostra. La fragilità di questo piccolo oggetto, piuttosto una tenda che un solido spazio espositivo, ha richiesto cure continue e affrontato restauri significativi.
La mostra ne ripercorre le tracce focalizzando sui tre eventi principali: il primo, nel 1976, guidato dall’architetto danese Fredrik Fogh con una squadra di carpentieri di Burano; il secondo, nel 1993, curato dal professor Panu Kaila e trasformato in un cantiere scuola con studenti di architettura finlandesi assistiti da operai specializzati italiani; l’ultimo, che nel 2012 ha dovuto far fronte ai danni provocati dal crollo di un albero, affidato all’architetto italiano Gianni Talamini.
Oggi, dunque, il padiglione è profondamente cambiato: pensato come provvisorio e smontabile, anche per proteggerlo dal clima umido di Venezia e dei Giardini, di fatto il piccolo edificio è diventato permanente e l’intervento di Fogh (in soli 40 giorni) si è reso necessario per il profondo degrado dei materiali, costringendo peraltro ad una scelta radicale, la sostituzione del pino finlandese con il larice, l’uso di nuovi colori, compreso il blue o indaco, la protezione della copertura e dei suoi lucernai con l’introduzione di una sporgenza ispirata all’architettura giapponese e una doppia grondaia in rame per convogliare l’acqua piovana in una vasca sulla terrazza.
Basata sulla ricerca negli archivi che hanno rivelato una puntuale documentazione fotografica, la storia del padiglione e delle mani che lo hanno curato negli anni diventa la dimostrazione della vitalità dell’architettura e una lezione del profondo legame di questo Paese con la propria storia.
Chi ha assicurato la longevità del padiglione può essere considerato co-autore dell’opera che non è più quella consegnata dalle mani di Alvar e Elissa: questo è il messaggio dei curatori, che insistono sul concetto di effimero dell’ambiente costruito. “Il padiglione, costruito come struttura temporanea è diventato un monumento permanente, mentre oggi molti edifici progettati per durare sono demoliti in meno di 50 anni […] La nostra mostra esplora la cura e la gestione dell’ambiente costruito, che ne rende possibile l’uso continuativo di generazione in generazione”, afferma Matti Jänkälä.
Immagine di copertina: interno del padiglione dei Paesi Nordici ai Giardini della Biennale di Venezia, 2025 (@Marco Zorzanello, courtesy La Biennale di Venezia)
Industry Muscle: Five Scores for Architecture
Padiglione Paesi Nordici alla 19^ Biennale di Architettura di Venezia
Sede: Giardini
Commissari: Carina Jaatinen, Architecture & Design Museum Helsinki, Finland; Yngvill Aagaard Sjöösten, The National Museum of Norway; Karin Nilsson, ArkDes, Sweden
Curatore: Kaisa Karvinen
Espositori: Teo Ala-Ruona
Visitabile fino al 23 novembre 2025
The Pavilion – Architecture of Stewardship
Padiglione Finlandia (Aalto) alla 19^ Biennale di Architettura di Venezia
Sede: Giardini
Commissario: Katarina Siltavuori, Archinfo – Centro informazioni per l’architettura finlandese
Curatori: Ella Kaira, Matti Jänkälä
Espositori: Merle Karp, Jussi Hertz
Visitabile fino al 23 novembre 2025
Architetto, laureato nel 1986 alla Facoltà di Architettura di Firenze, è professore associato di Storia dell’architettura all’Università Politecnica delle Marche. Le sue ricerche, oltre la tesi di dottorato sulle chiese a pianta centrale del Rinascimento in Umbria, privilegiano i Paesi Nordici, in particolare Finlandia e Svezia, seguendo le traiettorie di viaggio degli architetti tra Baltico e Mediterraneo. Nel 2017 e 2020 è stato Visiting Scholar presso il Martin Centre for Architectural and Urban Studies e il St John’s College (Università di Cambridge). Dal 2015 è Visiting Professor presso la Silpakorn University di Bangkok. Ha promosso il Comitato scientifico per il Centenario di Giancarlo De Carlo presso l’Accademia Nazionale di San Luca, oltre a essere membro del Comitato scientifico del Centro Studi Vitruviani di Fano, fondatore e direttore della summer school “The Culture of the City. Understanding the Urban Landscape”, dal 2017 impegnata nei paesaggi della ricostruzione del terremoto. Tra le pubblicazioni recenti: The Journey to the North. The Italian Cultural Institute in Stockholm in the context of the relationships between Swedish and Italian Architects, in Enchanting Architecture (Five Continents, 2021); Franco Albini and Leslie Martin: a parallel working life, in Postwar Architecture Between Italy and the UK. Exchanges and transcultural influences (UCL Press, 2021)