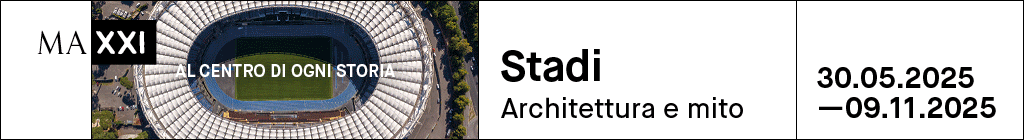Elogio della panca, sinonimo di accoglienza
Camminare e sostare, un percorso nella città e nella storia. Fino alla cesura attuale in cui prevalgono i divieti
LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DELLO SPECIALE
Published 27 maggio 2025 – © riproduzione riservata
La panchina è un luogo di sosta, un’utopia realizzata. È l’ultimo simbolo di qualcosa che non si compra, di un modo gratuito di trascorrere il tempo e di mostrarsi in pubblico, di abitare la città e lo spazio. (Beppe Sebaste)
Componente degli edifici
C’è un nesso che lega il camminare alla sosta, il movimento alla pausa, il passo alla seduta. È un ritmo necessario, vitale, non solo fisiologico, ma culturale, su cui non si è riflettuto a sufficienza.
La città storica incorporava nell’architettura e nella vita quotidiana l’atto di concedersi una sosta, di potersi sedere: la città accoglieva il cittadino e lo straniero come in un grembo. Corpi in movimento e corpi in riposo. Il dispositivo della seduta non era occasionale, disgiunto, ma faceva parte di un sistema organico di strutture materiali e di pratiche sociali. Come non ricordare le panche in pietra dei palazzi rinascimentali di Firenze (tra questi palazzo Rucellai e Strozzi).
Le panche accoglievano il popolo, i famigli dei signori, ma nello stesso tempo svolgevano una funzione spaziale, risolvevano l’attacco a terra dell’edificio, come i cornicioni che mediavano il rapporto del piano della facciata con la trasparenza del cielo.
A Roma, Palazzo Farnese dominava la piazza antistante, offrendo alla cittadinanza una lunga seduta incorporata nella composizione del prospetto cui faceva riscontro il potente cornicione michelangiolesco. La capacità di integrare le sedute nell’architettura delle fontane era una costante nel Rinascimento e nel Barocco. Si pensi alla fontana, di Pietro Bernini, la barcaccia, ai piedi di Trinità dei Monti e alla spettacolare di Fontana di Trevi dove la seduta di travertino cinge lo specchio d’acqua appoggiandosi alla parete perimetrale dello spazio ribassato del complesso. La seduta accoglie e, nello stesso tempo, offre un punto di osservazione avvolgente.
Identità italiana
È a Roma, con il piano di Sisto V, che possiamo cogliere visivamente lo stretto rapporto del movimento e della pausa. I percorsi dei pellegrini per raggiungere le basiliche giubilari si sviluppavano su lunghi assi stradali in cui erano collocati, come poli di orientamento, imponenti obelischi. Erano anche punti di sosta: i basamenti e le fontane disposte ai loro piedi, offrivano momenti di pausa e di ristoro.
La città antica offriva al pedone un sistema di soste utilizzando le pieghe delle piazze, i basamenti dei monumenti, i sagrati delle chiese, le scalinate e le rampe. Nella vita quotidiana soglie, muretti e parapetti offrivano una pluralità di occasioni per sostare, rivelando una irresistibile attrattività per il pedone di passaggio e le comunità di vicinato. La sosta, la seduta erano integrate nel disegno del suolo, nella sua conformazione, potremmo dire nella sua porosità, nel suo spessore.
Era questa organicità a caratterizzare lo spazio pubblico delle città italiane, spazi definiti progettualmente, ma spesso spontanei, nati dall’uso e dalle stratificazioni come ci ha raccontato Bernard Rudofsky. Nella modernità, prima nei parchi e poi nelle grandi città, appaiono le prime panchine. Le panche in pietra del giardino dedicato a Jean-Jacques Rousseau a Ermenonville orientano lo sguardo dei visitatori, invitandoli alla meditazione e al silenzio. Sono dei prototipi.
Dalla Parigi di Haussmann all’High Line
Ma è nella città, lungo i boulevard, voluti dal barone Haussmann che si afferma la panchina come arredo urbano. Il movimento dei passanti, ma anche la loro sosta non sfuggono ai pittori impressionisti che faranno della panchina un tema ricorrente. Avanza l’arredo urbano, che diventa oggetto di design e di produzione industriale, ma il progetto di architettura e di paesaggio riesce a lungo a incorporare la seduta, integrandola nel disegno complessivo.
Si pensi a Antoni Gaudì, al parapetto seduta del parco Guell; a Jože Plečnik, alla sua passeggiata lungo il fiume Ljubljanica i cui argini sono modellati come sedute continue; ai sedili in pietra che Dimitri Pikionis inserisce lungo il percorso che conduce all’Acropoli di Atene; alla lunga panca che accompagna la direzionalità del muro di cinta del Padiglione di Barcellona di Mies van der Rohe; al sistema di piastre con cui Lawrence Halprin compone il Keller Fountain Park di Portland su cui siedono comodamente i visitatori; alla fontana di Richard Meyer, all’esterno dell’Ara Pacis a Roma, sul cui perimetro ampie panche di travertino accolgono turisti e passanti. A New York lungo il percorso della High Line le sedute sono magistralmente integrate nel progetto di architettura e di paesaggio
Rifugio e giaciglio, oggi negati
La panchina è entrata nella vita quotidiana, attraversa le nostre vite, segna lo spazio pubblico, ne costituisce l’essenza, offrendosi come dispositivo gratuito, accessibile a tutti. È lo spazio libero per raccogliersi in solitudine o aprirsi al dialogo e all’incontro; è il luogo delle storie di amore e di amicizia: non è un caso che sia entrato nella letteratura e nel cinema. Come non pensare alla panchina delle Notti bianche di Dostoevskij o quella desiderata dal Marcovaldo di Italo Calvino? Il cinema ne ha fatto uno spazio ricorrente nelle scenografie, si pensi alla panchina de L’avventura di Antonioni o a quella, mitica, di Manhattan di Woody Allen.
La panchina è anche un rifugio e un giaciglio per chi non ha una casa né un tetto. Questo mondo gentile e tollerante sta scomparendo: è in corso una battaglia contro gli immigrati, i vagabondi. Si fanno sempre meno panchine, si modificano quelle esistenti per impedire che ci si possa stendere. Le nuove hanno forme improbabili e respingenti.
È vietato sedersi, fermarsi, prendere posto e sedersi è divenuto un atto che attiene alla sfera commerciale, non è più un’offerta pubblica, gratuita. La scomparsa delle sedute nella città avviene nel silenzio, non si percepisce che è in atto una mutazione culturale, che la nozione di spazio pubblico sta cambiando, che è in corso un processo di privatizzazione che invade la trama pubblica della città, rendendola ostile nei confronti della popolazione più debole. La città sta diventando sempre meno accogliente, meno democratica, e la panchina, nella sua umile dimensione, lo testimonia.
In occasione della Biennale dello spazio pubblico, uno dei temi oggetto di discussione sarà proprio l’inclusione, applicata alla progettazione e gestione degli spazi pubblici contemporanei.
Immagine di copertina: la seduta di Palazzo Farnese, inaccessibile da anni per le misure antiterrorismo (© Flavio Graviglia)
Ha insegnato Urbanistica presso la Facoltà di Architettura di Pescara e ha diretto la rivista «Piano Progetto Città». È stato consulente del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e visiting professor presso la Harvard Graduate School of Design. Tra le sue pubblicazioni: L’idea di città. Teorie urbanistiche della città tradizionale (1994), Babele. La città della dispersione (2002), Le paure dell’urbanistica. Disagio e incertezza nel progetto della città contemporanea (2005), Il passo della città. Temi per la metropoli futura (2015), Tra suolo e clima. La terra come infrastruttura ambientale (2019), Bruno Zevi uomo di periferia (2022)