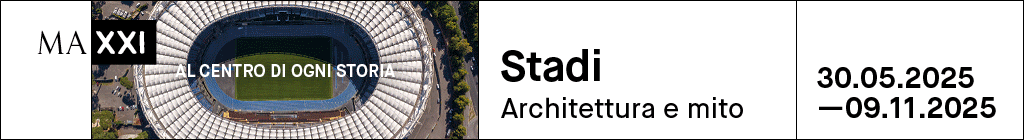De Rosa: serve un’architettura iposensoriale
Conversazione con Federico De Rosa, attivista e autore autistico, sui temi della progettazione
Published 6 maggio 2025 – © riproduzione riservata
In un mondo progettato da e per persone “neurotipiche”, chi è neurodivergente si muove in spazi che spesso ignorano – quando non escludono – le sue modalità di percezione e interazione.
Le categorie spaziali
La neurodivergenza non è una patologia. È una variazione del funzionamento neurologico che può riguardare, tra gli altri, persone autistiche, dislessiche, ADHD, ipersensibili.
Ognuna di queste condizioni comporta un rapporto specifico con il tempo, lo spazio, la luce, i suoni, le interazioni. L’ambiente costruito, però, tende a rispondere a un’idea normalizzata di utente, con conseguenze talvolta drammatiche per chi si discosta da questo modello. Nel caso dell’autismo, per esempio, lo spazio può amplificare disagi sensoriali o generare confusione comunicativa.
L’architetta egiziana Magda Mostafa, da anni attiva su questi temi, ha elaborato uno strumento progettuale (riportato sotto) chiamato ASPECTSS™ Design Index, che individua sette categorie spaziali da considerare per progettare ambienti compatibili con le esigenze delle persone nello spettro autistico: Acustica, Sequenza, Prossimità, Sicurezza, Transizione, Scala e Sensorialità. “L’autismo è una condizione neurologica che influenza il modo in cui una persona percepisce e interagisce con l’ambiente – scrive Mostafa -. In quanto tale, l’ambiente può essere progettato per facilitare o ostacolare questa interazione”.
La voce di Federico De Rosa
Eppure, ciò che vale per l’autismo vale in fondo per ogni forma di neurodivergenza. Se è vero che percepiamo e costruiamo il mondo attraverso i sensi e i linguaggi, allora uno spazio “inclusivo” non potrà che essere un esercizio continuo di traduzione tra visioni differenti. Come vivono lo spazio le persone neurodivergenti? Quali sono le difficoltà, ma anche le possibilità, che l’architettura può offrire?
Ne abbiamo parlato con Federico De Rosa, che ci restituisce uno sguardo radicale sul rapporto tra percezione, linguaggio e progetto.
L’intervista ci mette di fronte a un punto essenziale: lo spazio non è neutro, ma comunica, accoglie, respinge, orienta, confonde. E per chi si muove nel mondo con una mappa sensoriale diversa, questa comunicazione può fare la differenza tra inclusione ed esclusione. La neuroarchitettura, ancora agli inizi in Italia, rappresenta un campo di ricerca e di azione progettuale che interroga le basi stesse dell’architettura. Non basta prevedere “spazi accessibili”, se non si mette in discussione la normalizzazione percettiva su cui il progetto si basa. Il compito dell’architettura, allora, non è semplificare, ma tradurre, rendere leggibili e abitabili quelle differenze che ci attraversano tutti, neurodivergenti o neurotipici. E riconoscere che un ambiente capace di accogliere chi vive la realtà in modo “altro”, è un ambiente migliore per tutti.
Nel tuo libro L’isola di noi immagini una civiltà autistica, e da lì prende forma anche un’idea di abitare. Partiamo dalla casa: cosa significa, per te, una casa davvero a misura di persona autistica?
Come persona autistica, ci sono tante cose che si potrebbero fare per creare una casa molto più confortevole per noi. Innanzitutto, io – come molte persone autistiche – sono ipersensoriale e ho bisogno di una casa che riduca al minimo l’impatto sui miei sensi.
Qual è il primo aspetto che consideri problematico?
Il rumore. Soffro molto più dei non autistici per i rumori. Quindi vorrei una casa ben insonorizzata rispetto ai rumori esterni, ma anche capace di ridurre al minimo quelli interni, generati da porte, cassetti, piccoli o grandi elettrodomestici.
Pensi che ci siano strumenti concreti per migliorare questa condizione?
Sì, bisognerebbe istituire una certificazione di silenziosità degli appartamenti, suddivisa per classi. Questo spingerebbe l’edilizia e l’industria degli elettrodomestici a lavorare sull’inquinamento acustico. È un tema sottovalutato.
E per quanto riguarda la luce e i materiali?
Trovo eccessiva anche la luce solare diretta, ma questo si può gestire facilmente con delle tende. Quanto ai materiali, preferisco il legno chiaro a vivo: è molto riposante per l’occhio, naturale al tatto e non emana odori. Al contrario, alcune vernici usate nei mobili sono vere e proprie “armi da guerra olfattiva”.
C’è una regola generale che suggeriresti ai progettisti?
Sì: abbassare al massimo l’impatto sensoriale. È semplice, ma determinante.
Oltre al tema sensoriale, c’è anche una questione di funzionalità?
Assolutamente. Vorrei una casa semplice da far funzionare. A volte trovo dei miscelatori per doccia che sembrano progettati per chi ha una laurea in ingegneria meccanica. Ma la casa dovrebbe essere un luogo dove ci si rilassa, e tutto dovrebbe essere intuitivo e immediato da usare.
Secondo te è chiedere troppo?
Non credo. Sarebbe facile realizzare la prima vera casa per noi autistici.
Nel tuo libro immagini anche ambienti collettivi, come una scuola. Ce ne parli?
Sì. Ho immaginato una scuola autistica costruita in un bosco di querce e faggi. Sono alberi molto diversi: la quercia ha un tronco largo e una chioma a raggiera, il faggio è sottile, diritto, con la chioma alta anche quindici metri. Un bosco del genere sarebbe molto suggestivo.
E com’è organizzata questa scuola nel bosco?
Al centro, c’è la scuola. Nessuna strada per raggiungerla, solo una metropolitana completamente sotterranea, per non invadere la superficie. Ogni classe ha la sua aula e una radura nel bosco dove fare lezione, nelle giornate di bel tempo.
Una visione che sembra andare oltre una semplice “inclusione”…
Sì. Io non rivendico un’architettura “per” autistici. Propongo un’architettura semplice, iposensoriale, in cui anche i non autistici potrebbero vivere molto meglio. Gli amici che frequento più spesso me lo confermano. La mia non è una rivendicazione, ma una proposta: è il mio contributo autistico per un mondo più vivibile per tutti.
Immagine copertina: ritratto di Federico De Rosa e copertina di L’isola di noi. Guida al paese dell’autismo
Federico De Rosa
Federico De Rosa è un attivista, autore e speaker autistico, impegnato da anni nella promozione di una cultura dell’inclusione e della comprensione della neurodiversità. Ha pubblicato: Quello che non ho mai detto (San Paolo, 2014), L’isola di Noi (San Paolo, 2016) e Una mente diversa (San Paolo, 2020), opere in cui racconta il suo vissuto e offre una riflessione profonda sul modo in cui la società si rapporta alla diversità.
Dal 2015 De Rosa collabora con varie testate e progetti editoriali: ha gestito rubriche su Città Nuova, BenEssere e Vocazioni (rivista della CEI), ha scritto per i portali Fidene in Rete e Storie Correnti e dal dicembre 2021 cura un blog sulla salute per La Repubblica.
Dal novembre 2024 Ha collaborato alla preparazione del Giubileo 2025 con la Conferenza Episcopale Italiana.
Attraverso il suo sito Diversamente Felici, continua a raccontare il suo percorso, riflettendo su accessibilità, inclusione e felicità autentica.
Letture
https://iqd.it/architetti/magda-mostafa/
https://www.autism.archi/aspectss
Magda Mostafa, Marlene Sotelo, Toby Honsberger, Christine Honsberger, Erin Brooker Lozott, Nate Shanok, The impact of ASPECTSS-based design intervention in autism school design: a case study, 2024
Architetto e docente di Storia dell’Architettura e di Restauro presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio, Università della Svizzera Italiana. Affianca la ricerca storico-scientifica alla pratica professionale, integrando la progettazione con un aggiornamento continuo su tecnologie e materiali di ultima generazione.
Da oltre vent’anni
Studio Bettini Architetti
Associati si occupa di
restauro monumentale, riuso del costruito, allestimento degli interni.
Opera su commissioni
pubbliche e private nei contesti storici più delicati. Propone un approccio innovativo al design inclusivo
per sviluppare soluzioni progettuali che integrino accessibilità e inclusività, rispettando e valorizzando il patrimonio esistente.