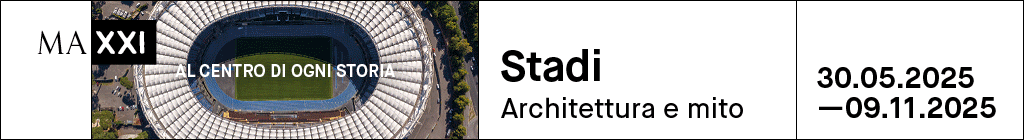La vertigine del quarto spazio
Concetti, suggestioni e visioni sulla rigenerazione urbana e sulle sue implicazioni
LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DELLO SPECIALE
Published 30 aprile 2025 – © riproduzione riservata
Nelle città europee contemporanee segnate dalla policrisi e guidate da un pensiero climatico è necessario anche innovare le forme, le funzioni e le relazioni tra gli spazi di vita. È venuto il tempo di superare la rigida frammentazione modernista della città tra primo spazio dell’abitare (le case), secondo del lavorare (gli uffici, gli esercizi commerciali, ma anche le strade e le piazze degli usi funzionali) e terzo spazio della convivialità (quei luoghi, spesso ibridi e recuperati dalla dismissione o dal degrado, che accolgono le attività culturali e creative e l’innovazione sociale).
La città aumentata del quarto spazio
Per aumentare la diversità bioculturale e la resilienza delle città voglio introdurre il concetto di “quarto spazio”, un insieme di luoghi che misceli consapevolmente, in modi differenti, le funzioni e le forme dei primi tre.
Uno spazio ibrido e della mescolanza che offra occasioni per la socialità di prossimità, per la convivialità extra-domestica, per il lavoro condiviso, per la salute psico-fisica e anche per le nuove modalità dell’abitare condiviso o temporaneo. Uno spazio capace di coniugare funzioni diverse, anche in diverse temporalità, e di accogliere bisogni plurali e non eteronormativi.
Il quarto spazio è un luogo di convivenza e contaminazione, senza una funzione predeterminata, che si modella attraverso l’uso, le relazioni, le posture e il tempo che le persone dedicano a viverlo.
Può presentarsi come un coworking che si trasforma in palestra e poi in sala per eventi, come una residenza temporanea condivisa tra giovani, lavoratori nomadi e anziani in cerca di una rinnovata mutualità, oppure come una piazza che alterna il mercato locale alle performance artistiche e all’educazione informale.
Il quarto spazio rifiuta l’omogeneità per accogliere la pluralità, la divergenza e la creatività. Nasce dall’inadeguatezza delle strutture tradizionali nell’accogliere le nuove forme di vita urbana.
La crescente diffusione del lavoro agile, l’emergere di nuclei familiari non convenzionali, la crisi dell’edilizia residenziale e la crescente domanda di luoghi flessibili e accessibili hanno generato una pressione crescente sul sistema spaziale delle città, e il quarto spazio risponde a queste sfide non con soluzioni rigide, ma attraverso configurazioni porose, mobili e partecipate.
Il quarto spazio è uno spazio post-funzionalista, che rifiuta la zonizzazione in favore dell’adattabilità, in cui l’utente non si adatta al luogo, ma lo modella, lo plasma e lo reinventa. In esso si manifesta una nuova idea di comunità, fondata non tanto sulla prossimità fisica o sull’omogeneità sociale, quanto sulla capacità di convivere nella differenza, sull’ibridazione delle temporalità, delle posture e dei linguaggi.
In questo senso, il quarto spazio può essere letto come una forma attuale dell’eterotopia foucaultiana: uno spazio altro, che raccoglie e rifrange le tensioni del presente e che, pur essendo inserito nel tessuto urbano, se ne distingue per la capacità di riorganizzare simbolicamente e pragmaticamente le relazioni spaziali e sociali.
Vertiginoso e infinito
La sua natura evolutiva lo rende uno strumento potente di rigenerazione urbana. In molte città, il quarto spazio ha manifestato i suoi indizi impliciti, e talvolta forme compiute e consapevoli, nella riconversione di edifici industriali dismessi, nella riattivazione di cortili scolastici, nella trasformazione di terrazze in orti collettivi o di biblioteche in spazi polivalenti.
Questi interventi non sono semplici operazioni di riuso, ma azioni di ricomposizione territoriale e sociale, capaci di restituire centralità a luoghi marginali e di innescare processi di cura collettiva dello spazio.
Rigenerare attraverso il quarto spazio significa agire con accuratezza ma con radicalità, introducendo nuovi usi in spazi abbandonati o sottoutilizzati, senza cancellarne la memoria, ma amplificandone le potenzialità latenti.
Quello che lo rende veramente distintivo è la sua capacità di ospitare la molteplicità. È uno spazio inquieto che non impone un ordine, ma accoglie una pluralità di ritmi, esigenze, funzioni e forme di vita: è uno spazio in cui le differenze non si annullano, ma si riconoscono e si rafforzano reciprocamente.
Non si tratta quindi di immaginare una nuova tipologia architettonica o urbanistica, ma di introdurre una nuova sensibilità progettuale, capace di cogliere il potenziale trasformativo degli spazi in attesa, dei margini, delle intercapedini urbane, dei relitti e dei dispositivi parassiti. Nella mia concezione il quarto spazio è uno spazio aperto, incompiuto, potenzialmente infinito, che si costruisce attraverso un processo continuo di adattamento, manipolazione e reinterpretazione.
Non si configura come una forma univocamente definita ma come una lista potenzialmente infinita – come ci ha svelato Umberto Eco – e “vertiginosa” poiché accoglie tutto ciò che non è ancora stato immaginato, progettato, realizzato, e che sta oltre la soglia di un “eccetera” che è solo l’inizio di infinite ulteriori possibilità.
Lo spazio-lista contiene tutto ciò che i fruitori riescono a sognare, ammirare, domandare, abitare, usare, attraversare, toccare, forgiare, comprare, vendere, odorare, ascoltare, leggere, percorrere, contemplare, spostare, aggiungere, sottrarre, condividere, sudare, sovrastare, scavare, innalzare, eccetera.
Gli immobili pubblici come generatori
Tra le risorse più preziose per l’attivazione e la diffusione del quarto spazio vi sono senza dubbio gli immobili pubblici, in particolare i grandi patrimoni appartenenti al demanio statale, oggi in gran parte dismessi o sottoutilizzati.
Monasteri, caserme, palazzi per uffici, complessi scolastici e ospedalieri dismessi rappresentano una riserva potenziale di spazi a forte valore identitario, distribuiti capillarmente nel tessuto urbano e territoriale italiano, spesso collocati in posizioni strategiche, centrali o di cerniera.
Per dimensioni e struttura, questi edifici offrono una flessibilità intrinseca che li rende perfettamente adattabili alla logica del quarto spazio: possono ospitare residenze temporanee, spazi di coworking, laboratori artigianali, servizi di prossimità, attività culturali, spazi per il benessere, l’istruzione informale o la cura.
La commistione di spazio pubblico e funzioni collettive stimola il progetto architettonico a interrogarsi su ibridazione e porosità degli spazi, su infrangere barriere e lavorare per interfacce, su come comporre edifici e “spazi chimera”, meravigliosamente biodiversi, al posto di algidi edifici monofunzionali.
Spazi composti da parti diverse che li rendono più pubblici, più aperti, più vegetali, più accoglienti, prendendo da ogni specie di spazio la sua caratteristica migliore per farne punto di forza, adattando il meglio da ogni parte. La loro riconversione in quarto spazio favorirebbe economie locali, nuove reti di solidarietà e processi di rigenerazione sociale e ambientale.
Gli immobili pubblici devono tornare a essere una riserva di spazi di socializzazione per la città, aprendo il loro terzo spazio implicito e attivando il quarto spazio, diffondendolo nei quartieri e estendendo lo spazio pubblico senza doverlo realizzare in tessuti spesso troppo densi, inserendo anche porzioni di residenzialità (studentati, foresterie, co-living) per accogliere le nuove e diversificate domande dell’abitare contemporaneo.
Le scuole, in particolare, offrono un ampio spettro di potenzialità per accogliere meglio non solo i naturali utilizzatori (le allieve e gli allievi), ma anche persone che fruiscano dei loro spazi aumentati dalla miscelazione, ricchi di diversità bioculturale. Esse possono aumentare in maniera significativa il quarto spazio dei quartieri, per la loro diffusione e per la loro funzione pedagogica che può estendersi anche a una nuova educazione alla città.
Con lo stesso approccio ampio, dovremmo realizzare i luoghi della cura come quarto spazio, dove, insieme alla funzione della degenza, si possano trovare bellezza e sicurezza anche in tutti quegli ambienti e aree che accolgono, smistano, fanno attendere, permettono una passeggiata, offrono paesaggio o, inevitabilmente, consentono il commiato.
Serve un pensiero rigenerativo che coinvolga tutte le forme di presidi socio-sanitari (ospedali, centri riabilitativi, residenze per anziani, presidi socioeducativi per le persone neurodivergenti) perché tornino ad arricchire i quartieri di luoghi della cura, del benessere e del mutualismo, anche come occasione di arricchimento e formazione del quarto spazio di quartiere.
Il quarto spazio, quindi, è un progetto di città, poiché non va solo attivato ma deve essere progettato reclamando una nuova urbanistica: non più solo normativa e prescrittiva, ma capace di progettare la possibilità. Il quarto spazio non richiede soluzioni definitive, ma si offre come campo di sperimentazione, terreno fertile per una progettazione urbana fondata sull’ascolto, sulla flessibilità e adattabilità degli usi, sulla pluralità delle persone e sulla meraviglia dell’imprevedibile.
Immagine di copertina: schema interpretativo del quarto spazio, elaborazione dell’autore
Maurizio Carta (Palermo, 1967) è professore ordinario di urbanistica presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo. Attualmente è assessore alla rigenerazione urbana, sviluppo urbanistico della città policentrica e mobilità sostenibile del Comune di Palermo. Tiene lezioni e svolge attività di ricerca in numerose università, tra cui la Columbia University di New York, l’Institut d’Urbanisme de Paris, la Leibniz University di Hannover. Dal 2017 dirige l’Augmented City Lab, dedicato alle città sostenibili del futuro prossimo. Nel 2024 è stato insignito del Primo Premio Luigi Piccinato per l’urbanistica. È autore di più di 350 pubblicazioni scientifiche in Italia e all’estero, le cui più recenti sono: Città aumentate (Il Margine, 2021), Palermo. Biografia progettuale di una città aumentata (LetteraVentidue, 2021), Cosmopolitan Habitat (Jovis, 2021), Resilient Communities and the Peccioli Charter (Springer, 2022), Homo urbanus (Donzelli, 2022), Palermo, un’idea di cui è giunto il tempo (Marsilio, 2023), Romanzo urbanistico (Sellerio, 2024).