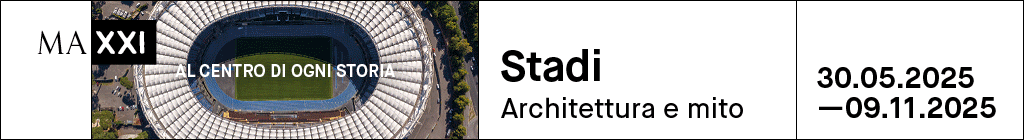Ripartire dall’esistente, il futuro è lì
Intorno alla rigenerazione urbana: visioni e orientamenti per gli habitat contemporanei
LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DELLO SPECIALE
Published 7 maggio 2025 – © riproduzione riservata
Nell’ambito di un ciclo di video-conferenze (“The present of the present”, Università Federico II, maggio 2020, intorno alla concezione del tempo in sant’Agostino) Maria Giuseppina Grasso Cannizzo definiva in modo magistrale il significato e il valore della città esistente: “Le decisioni implicano senso di responsabilità, tempo e consapevolezza […] affidando all’architettura il compito di governare il processo di trasformazione del mondo abitato in un mondo diversamente abitabile in modo da assicurare a tutti protezione e cura […] Le risposte andranno date tenendo a mente che la costruzione di quel mondo diversamente abitabile dispone di un unico materiale da costruzione: l’esistente”.
Patrimonio pubblico e rigenerazione urbana
Rispetto a questa considerazione, così rilevante, siamo ancora in grado di dare risposte? Siamo capaci di proporre soluzioni che si facciano carico di mettere in opera relazioni, necessità, dialogo ed inclusione?
È necessario, dunque, riconoscere nell’esistente un valore per la città contemporanea, il terreno comune su cui avviare i processi di trasformazione, operando attraverso strategie e azioni capaci di produrre le nuove dimensioni del progetto, fatte di adattamenti, aggiunte e riduzioni. Nuove categorie che favoriscono la pratica di quella che possiamo definire come la pratica della messa a sistema.
L’esistente presuppone, in questo senso, la necessità di definire una avanzata attitudine progettuale che ricorre agli strumenti del recupero ed alla rigenerazione del contesto, considerando la demolizione come ipotesi estrema, una posizione antagonista a quella della tabula rasa, che riconosce proprio nell’esistente, oltre alla sua consistenza fisica e materiale, il luogo di informazioni, conoscenze, strati, memorie e vite da conservare.
Il cambio di paradigma vede nel patrimonio pubblico esistente il principale potenziale trasformativo per il futuro delle nostre città, in generale in tutta Europa ma in modo specifico in Italia. Una grande opportunità per costruire un futuro sostenibile ed un habitat capace di adattarsi alla permanenza di queste strutture, aree e volumi di proprietà pubblica, spesso collocati in punti strategici, all’interno di maglie densamente costruite, che hanno la capacità di accogliere programmi, funzioni e spazi e che offrono la possibilità di aumentare la realtà di luoghi di prossimità, quartieri ed intere parti di città.
Le novità normative intervenute in questi ultimi anni, e la possibilità di governare e gestire i processi di trasformazione attraverso procedure e finanziamenti non solo pubblici ma anche privati, hanno prodotto un radicale cambiamento nella valutazione e nel ruolo del patrimonio pubblico esistente.
I modelli per la trasformazione e gestione dei beni pubblici offrono diverse possibilità. Dalla gestione diretta o di soggetti terzi, ai partenariati e alle fondazioni, fino alle imprese multi-stakeholder, l’attuale quadro normativo offre un ampio ventaglio di opportunità testimoniato oggi in Italia da alcune pratiche avanzate, che assumono il ruolo di modello per un settore così importante e strategico.
Di assoluto rilievo alcune recenti esperienze milanesi, benchmark del modello di governance e non solo, che hanno attivato un processo di trasformazione del patrimonio pubblico esistente: BASE Milano e la Fabbrica del Vapore e la significativa esperienza, anche se di proprietà privata, di Upcycle Milano bike Cafè.
Queste esperienze dimostrano che Il patrimonio non deve essere più considerato in una visione statica, quale complesso dei beni patrimoniali dell’attore pubblico (di cui deve essere assicurata la conservazione, aspetto di assoluto rilievo) ma deve essere inquadrato in una visione dinamica, quale strumento strategico della gestione finanziaria, cioè come complesso delle risorse da utilizzare per il perseguimento di obiettivi economici, sociali e culturali a vantaggio della collettività di riferimento.
Questa visione sta acquisendo maggiore rilievo negli ultimi anni, in previsione della realizzazione di numerosi programmi di rigenerazione urbana che, per avere successo, dovranno attuare, equilibrate pratiche di governance in un reale e completo sistema di trasformazione e sviluppo.
Attualmente in Italia non esiste una definizione univoca del concetto di rigenerazione urbana. In generale è un’azione volta a risolvere le problematiche e le fragilità in ambito urbano e a realizzare un miglioramento a lungo termine degli aspetti economici, fisici, sociali e ambientali di un’area o di un edificio da trasformare.
Sebbene la ricostruzione fisica sia ancora una componente cruciale, gli obiettivi principali tendono ad essere la promozione della crescita economica, la riduzione delle diseguaglianze sociali e il miglioramento della coesione della comunità.
I principali outcome di questo processo sono numerosi: l’ambiente (attraverso la riduzione di emissioni inquinanti e gas serra, e la piantumazione e realizzazione di nuove aree vegetali e permeabili), il lavoro e la crescita economica (incrementando l’occupazione diretta ed indiretta), la comunità sostenibile (aumentando la partecipazione culturale e sociale, realizzando maggiori spazi pubblici e favorendo l’housing), le infrastrutture e la viabilità (attraverso mobilità alternative e l’aumento delle aree pedonali e ciclabili), l’efficientamento energetico (con il miglioramento energetico dell’esistente, incrementando l’energia prodotta da fonti rinnovabili).
Un progetto per Taranto
In questo contesto, l’esperienza del progetto di recupero di Palazzo Frisini a Taranto, promosso dalla Regione Puglia, propone, all’interno del più generale quadro dei processi di trasformazione del patrimonio pubblico esistente, una pratica adattiva che, nel conservare i valori e la memoria dello storico edificio, costruisce un modello funzionale, finanziario e di governance che propone modelli ibridi per trasformare gli spazi esistenti, potenziando le relazioni tra l’esistente ed i luoghi di prossimità.
Nell’edificio, di proprietà della Provincia di Taranto e affidato in gestione ad Adisu Puglia, si propone di unire in un unico spazio l’offerta di residenze universitarie con nuovi servizi aperti al pubblico, rendendoli integrati e compatibili con i servizi già presenti, sia a livello di quartiere, che di città.
L’intento è quello di insediare una comunità in grado di interagire con il contesto urbano. Per questa ragione si è scelto di mantenere un piano terra urbano aperto, che si integri perfettamente con le necessità funzionali dello studentato. Una grande piazza protetta, quindi, dove ritrovarsi e sperimentare la socialità. Una nuova via urbana attraverso il cortile diventa connessione all’interno del quartiere. Una terrazza eventi per l’intera città, uno spazio flessibile che, a seconda delle esigenze, si accenderà in modo diverso.
Nuove relazioni tra lo spazio aperto pubblico e lo spazio interno collettivo del piano terra sono enfatizzate dai sistemi di accesso all’edificio. Qui sono previste aree di accesso/accoglienza/ricevimento e di incontro, aree funzionali per servizi culturali e didattici, “servizi ricreativi” dedicati agli studenti residenti ma anche aperti alla fruizione pubblica.
Il progetto nasce all’interno del programma Puglia Regione Universitaria ed è in corso di realizzazione. La fine dei lavori è prevista per il 2027. Il tema delle residenze per studenti universitari offre la possibilità di una duplice chiave di lettura: è un luogo di sperimentazione di modelli abitativi e allo stesso tempo uno straordinario strumento di rigenerazione urbana per la trasformazione del patrimonio pubblico esistente. La pratica dei processi di trasformazione del patrimonio pubblico esistente mette in evidenza una condizione che trova risposta solo nella ampiezza e nella complessità di procedure che legano le questioni urbane alla disponibilità delle risorse, attraverso modelli di governance capaci di produrre reddito anche in termini sociali e culturali. Il caso di palazzo Frisini a Taranto – nell’immaginare gli spazi della vita in comune, i luoghi della condivisione, i temi di un nuovo e allo stesso tempo antico immaginario – prova a costruire quella necessaria integrazione tra politiche universitarie e politiche urbane, che rappresentano il reale obiettivo di un processo di trasformazione.
Immagine copertina: Palazzo Frisini, Taranto, il progetto vincitore del concorso in due fasi, dello studio Corvino+Multari
Giovanni Multari (Cosenza, 1963) fonda a Napoli con Vincenzo Corvino lo studio Corvino+Multari (1995). Insegna Progettazione Architettonica ed Urbana presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Architettura. Fra i progetti realizzati: il restauro del grattacielo Pirelli a Milano e il restauro, rifunzionalizzazione e riqualificazione energetica del Museo e Real bosco di Capodimonte. Tra i principali riconoscimenti la Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana nel 2006 e il Premio Nazionale IN/ARCH 2023. Tra le sue pubblicazioni più recenti si segnala Corvino + Multari. L’architettura dialoga con la città per Marsilio Arte (2025).