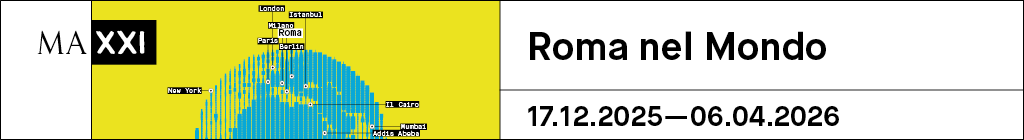Laboratori sociali per l’interazione
Riferimenti ed esperienze di inclusione e partecipazione: verso la condivisione degli spazi e un’urbanistica meticcia
LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DELLO SPECIALE
Published 30 settembre 2025 – © riproduzione riservata
Si è svolta a metà settembre, all’ex Mattatoio di Roma, l’ottava edizione della Biennale dello Spazio Pubblico. Evento ricco e partecipato che permette di riflettere su progetto e caratteri dei luoghi collettivi nelle città contemporanee, sotto il titolo “insieme / together / juntos”. Il Giornale dell’Architettura, media partner, ha già dedicato alcuni articoli di avvicinamento all’iniziativa. Offriamo ora commenti e punti di vista da parte di docenti e critici che hanno coordinato alcune sessioni: vogliono essere un bilancio dei temi discussi e soprattutto un’apertura alle questioni più significative che lo spazio pubblico contemporaneo genera.
Nell’ambito della Biennale dello Spazio Pubblico, che ha proposto il confronto e la divulgazione delle attività di ricerca e delle azioni svolte sui temi degli spazi pubblici territoriali e urbani che esprimono valori di inclusione e di partecipazione, si è tenuta la sessione tematica Insieme nell’inclusione sociale.
L’obiettivo dell’incontro, che ha visto l’ampia partecipazione di associazioni, enti pubblici, studenti, fondazioni, è stato quello di attribuire senso e valore, mediante riflessioni teoriche ed esempi pratici, al concetto di inclusione sociale applicato alla valorizzazione degli spazi.
Rimuovere le barriere
Inclusione come abbattimento delle barriere, diritto fondamentale a prescindere dalle condizioni e dalle capacità individuali, inevitabilmente connesso al concetto di interazione (esaminato nella sua dialettica con il controverso termine integrazione), tra persone e tra culture, laddove è nell’incontro e negoziazione tra diversità che si generano nuove opportunità e pace e benessere sociale.
Si è, quindi, discusso di innovazione sociale, di politiche, progetti, pratiche educative e organizzative caratterizzate da un forte senso di comunità, cooperazione e condivisione per rimuovere barriere fisiche, sociali e culturali, promuovendo diritti e opportunità, appartenenza e accoglienza; di accesso equo alle risorse e ai servizi; di contrasto alla marginalizzazione e all’isolamento di individui o gruppi, specie quelli più marginali; di partecipazione attiva di cittadini, istituzioni e associazioni; di costruzione di competenze e capacità.
All’interno dei diversi interventi sono emerse numerose piste di riflessione. Ad esempio, come ha indicato Simone Guarna, il tema della costruzione di fiducia come primo passo di rimozione delle barriere, vista la difficoltà che in molti casi si riscontra nel coinvolgere le persone nei processi di partecipazione.
Lo ha segnalato anche Beatrice Sansò raccontando un caso di rigenerazione partecipata a Caracas che ha proprio fatto leva sulla creazione di reti di fiducia e senso di appartenenza. A questo fine Sansò ha indicato tre ambiti su cui lavorare: informazione, partecipazione e negoziazione (tema centrale messo in evidenza anche da Claudio Gnessi). Ma questi processi, per prendere forma, hanno bisogno di spazi fisici, di laboratori sociali – come ci ricorda Nicoletta Imbesi – in cui si possa lavorare sui temi della memoria, della contemporaneità e dell’integrazione, in un “tempo libero che è il tempo in cui tutti sono uguali”; spazi di costruzione di identità non come concetto ideale, ma strumento pratico di miglioramento della qualità della vita, anche mediante una urbanistica tattica sottolineano Elio Salvador e Martinez Joffre.
Spazi fisici che devono essere abitati, laddove in una città porosa gli spazi pubblici e privati si devono mischiare, senza trasformarsi in scenografia urbana come indica Flavio Graviglia criticando tutti quei luoghi della capitale che oggi non sono più abitabili.
Spazi – ci ricorda Marco Pacciotti – per la condivisione di cultura e di relazioni, come le biblioteche, ma anche per quel tempo libero sopra segnalato e abitabile in luoghi come i centri anziani che oggi potrebbero essere ripensati e valorizzati con uno sguardo al futuro.
Gestione collaborativa degli spazi
In questo quadro, e questa è una seconda pista che è emersa con chiarezza nel corso della discussione, i soggetti che si muovono dal basso hanno un ruolo assolutamente decisivo.
A partire dalle associazioni, come segnala Vincenza Miletti, vera barriera al degrado, e come emerge chiaramente dagli interventi di Giovanni Germano, Antonio Seibusi e Fridanna Maricchiolo (testimoni dell’impegno per la rigenerazione delle aree più fragili), e Claudia Bernabucci e Michela Diodato che hanno mostrato la rilevanza dei patti di collaborazione per la gestione degli spazi, in cui tutti gli attori del territorio devono essere presenti e partecipi.
Per arrivare al ruolo centrale della scuola e dei processi educativi, come è emerso con chiarezza dagli interventi di Maria Pia Ercolini (perché per affrontare le disuguaglianze di genere è dai più piccoli che occorre ripartire), Valeria Procaccini (con la potente presentazione di un suo gruppo di studenti di Foggia), Letizia Montalbano e Fulvia di Francesco che ha parlato di accoglienza dei minori non accompagnati.
Affinché tutto ciò possa avvenire, e questa è la terza pista, occorre ripensare completamente il senso del dialogo e dell’interazione. Stefano Veglianti ha parlato di tavoli della convivenza, Gnessi di costruzione di valore comune, valore appunto come frutto di un patto negoziale. La città di Roma, quindi, come città sempre più meticcia ha necessità di essere letta con le chiavi di una urbanistica meticcia, segnala ancora Veglianti, in grado di operare con uno sguardo ed una visione di futuro, che misuri e promuova il valore del suo patrimonio in termini di valore collettivo.
Le pratiche presentate, in conclusione, diverse nella rappresentazione tematica, ma accomunate dall’obiettivo di dare a tutte e tutti, al di là delle proprie caratteristiche personali, le stesse possibilità di accesso all’istruzione, alla salute, al lavoro, ai servizi, hanno messo a fuoco quanto sia importante sentirsi parte di un gruppo o di una società, in cui le differenze di ciascuna/o siano riconosciute e valorizzate, e in cui la costruzione di valore sia un processo condiviso, partecipato e negoziale.
Immagine di copertina: Sabana Grande Boulevard, Caracas (Venezuela)
Svolge attività di consulenza e formazione sui settori culturali e creativi per organizzazioni pubbliche e private realizzando ricerche, progetti, analisi di scenario, piani strategici, studi di impatto, valutazioni. È codirettrice della rivista mensile Letture Lente (AgCult) e impegnata in progetti di sviluppo locale a base culturale. Ha pubblicato numerosi saggi e libri tra i quali: Mappa delle diseguaglianze di genere (Editrice Bibliografica, 2024); Integrating and monitoring culture in the Sustainable Development Goals (SDGs) framework, in “Economia della Cultura” 2-3/2024; A Cohesive Voice for Europe: Public Service Media responding to contemporary challenges in “The Future of Public Service Media in Europe”, Public Value Text (2025).