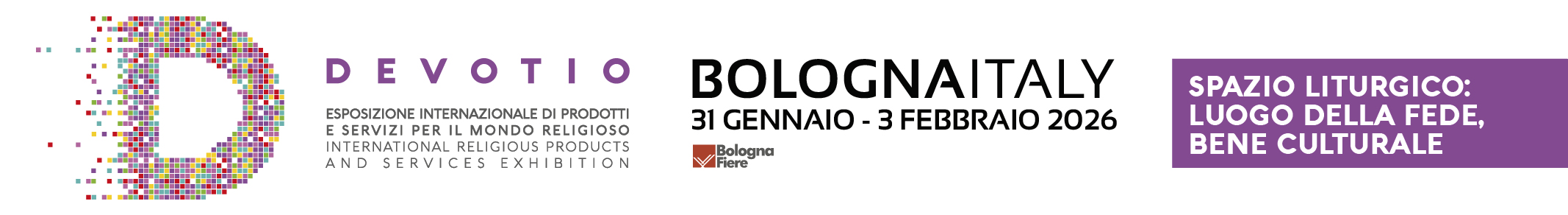Santa Sede
Architettura come arte dell’incontro sull’isola di San Giorgio
Published 23 maggio 2023 – © riproduzione riservata
In una Biennale in cui l’architettura – come costruito e rappresentazione del costruito – occorre andarla a cercare col lumicino, il padiglione della Santa Sede individua una direzione precisa per la disciplina, ancorandola a una chiara visione sociale e teologica, dunque a un peculiare orizzonte sapienziale che, forse, è proprio ciò che oggi più d’ogni altra cosa all’architettura manca. I risultati non sono eclatanti o monumentali e pertanto, al di fuori di una comprensione del quadro ispirativo dell’intervento, potrebbero restare invisibili, non fosse per la punteggiatura offerta da Alvaro Siza che interviene disegnando figure antropomorfe a intrecciare sguardi e gesti d’accoglienza dalla loro tetragona staticità lignea. Sarebbero fors’anche potute bastare le due erme cilindriche in marmo per traguardare il corpo di fabbrica del convento e condurre nell’orto, vero nucleo significativo della proposta.
La differenza con la precedente partecipazione della Santa Sede alla Biennale (2018) è già nella toponomastica e nella scelta dei luoghi: là era un giardino, luogo originario e mitico per una natura da contemplare, qui si tratta di un orto, ossia di uno spazio da “coltivare e custodire” (LS, 67), animali da cortile inclusi – galline e tartarughe nella fattispecie -, per attivare processi d’incontro, scambio e condivisione. Là si trattava di una (controversa) permanenza, qui si tratta di esibita provvisorietà. Là l’ente organizzatore era il Pontificio Consiglio della Cultura, presieduto dal cardinale Gianfranco Ravasi; qui, a valle della riforma della Curia Romana (19 marzo 2022), l’ente organizzatore è il neonato Dicastero per la Cultura e l’Educazione, il cui prefetto è il cardinale José Tolentino de Mendonça. Tra le due presenze, lo scarto è anche quello della pandemia, alla quale la Chiesa ha reagito con un nuovo monumento della sua dottrina sociale: l’enciclica Fratelli tutti (3 ottobre 2020), un inno all’«amicizia sociale» nel medesimo tempo in cui l’emergenza pandemica di sociale prevedeva al contrario il distanziamento, inasprendo la prigionia delle solitudini che affaticano la società contemporanea.
Così, mediante un orto si precisa e si concretizza un monito che era già all’esordio del pontificato di Francesco, conseguenza di quel principio di prevalenza del tempo sullo spazio che conduce non a occupare spazi, bensì ad avviare processi (EG 223). Un orto innesta l’uomo nella ciclicità delle stagioni, lo accorda al ritmo del cosmo e altrettanto impone a una comunità un’organizzazione per lavorarlo e per condividerne i prodotti, nella “certezza della destinazione comune dei beni della terra” (FT 124).

Quest’anno il padiglione della Santa Sede rifiuta di essere solamente l’esito di un lavoro a tavolino, fors’anche perché “le grandi trasformazioni non si costruiscono alla scrivania o nello studio” (FT 231). Lo Studio Albori (Emanuele Almagioni, Giacomo Borella, Francesca Riva) si è messo all’opera con gli attrezzi del mestiere che sono anche cacciaviti, vanghe e martelli oltre a piante prospetti e sezioni qui finalmente messi in mostra. Il risultato non è uno spazio formalmente compiuto ma un laboratorio in fieri, esso stesso prodotto di un processo in cui le piantumazioni presenti vengono potate, e di nuove ne vengono insediate in una collaborazione con l’Associazione culturale veneziana About (Agostino Vazzoler, Michela Valerio, Riccardo Bermani) che estenderà qui a San Giorgio le attività e le esperienze già avviate a San Giacomo all’Orio, di un’attività di giardinaggio come pratica sociale e partecipativa.
Nell’orto, l’architettura interviene in modo leggero, come arte che ordina lo spazio a partire da ciò che c’è, riorganizzando quanto disponibile: allora l’ex pollaio diventa un semplice pergolato sotto una stuoia che proprio a San Giorgio aveva lasciato un precedente allestimento del padiglione del Qatar. Le sedie vengono da una vecchia installazione alla Bicocca a Milano, e tutti gli altri materiali per i due padiglioni che a sud e a nord concedono un’isola d’ombra attorno a piccoli chioschi sono recupero di cantieri veneti, con gli infissi e le porte che provengono da una casa a Cortina.
Non c’è tuttavia solo praticità e funzione: un’altana è data come belvedere alla contemplazione dell’orto ai cui percorsi il curatore, Roberto Cremascoli, con lo Studio Albori, ha voluto conferire il profilo di un pesce, per lasciare, al visitatore accorto, l’antico cristogramma come dichiarazione di origine di questo spazio che nelle sue costruzioni non ha muri (FT27) ma solo esili pilastri, e livellamenti e compensazioni degli antichi percorsi per risolvere con lievissime rampe ogni differenza di quota. La cura conferita allo spazio è puntuale quanto discreta (forse sulla scia di Mt. 11,25…?) e non è volta al nitore formale, quanto piuttosto a favorire la partecipazione e l’inclusività sociale che consegna a Venezia non uno spazio-esibizione, ma – finalmente – un luogo di vita, un lacerto di terra che potrà ereditare non come fardello ingombrante, ma come leggero spazio d’incontro.
Indice delle abbreviazioni:
EG – Esortazione apostolica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francesco sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale (24.11.2013)
LS – Lettera enciclica Laudato si’ del Santo Padre Francesco sulla Cura della Casa Comune (24.05.2015)
FT- Lettera enciclica Fratelli tutti del Santo Padre Francesco sulla fraternità e l’amicizia sociale (3.10.2020)
Nato a Bologna (1977), vi si laurea in Ingegneria edile nel 2003. È ricercatore presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna, ove nel 2008 ha conseguito il dottorato di ricerca in Composizione architettonica. Si occupa specialmente dei rapporti tra sacro e architettura, in collaborazioni formalizzate con la Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna ove è professore invitato per seminari attinenti alle relazioni tra liturgia, paesaggio e architettura. Presso la Scuola di Ingegneria e Architettura di Bologna insegna Composizione architettonica e urbana, ed è stato docente di Architettura del paesaggio e delle infrastrutture. È collaboratore de “Il Giornale dell’Architettura” e direttore della rivista scientifica del Dipartimento, “in_bo. Ricerche e progetti per il Territorio, la Città, l’Architettura”