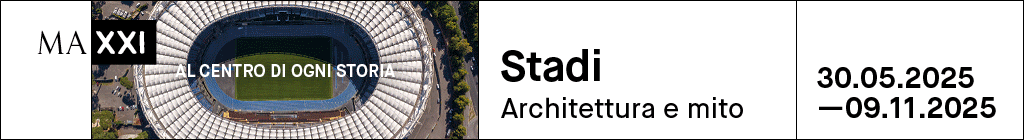Resto del mondo
Quarta rivoluzione industriale, declinazioni della decolonizzazione e decarbonizzazione, acqua ponti e connessioni
Published 23 maggio 2023 – © riproduzione riservata
Australia: Unsettling Queenstown
Queenstown, toponimo molto diffuso in tutto l’ex impero britannico, diventa la chiave di lettura per leggere il colonialismo come elemento di sovrascrittura del territorio aborigeno e d’imposizione di nomi e simboli britannici ai territori indigeni. Al centro del padiglione un frammento di architettura coloniale, il modello in scala dell’Empire Hotel realizzato in tubi di rame, campeggia su un letto di foglie di eucaliptus per imporre di affrontare la necessaria questione della decolonizzazione. La mostra indaga le relazioni tra le persone e l’ambiente nell’ottica del colonialismo e dello sfruttamento delle risorse che avviene nelle Queenstown reali e immaginarie. Anche in questa edizione il padiglione australiano, il più recente ai Giardini realizzato su progetto di Denton Corker Marshall nel 2015, non sembra sfruttare appieno le proprie potenzialità.
Austria: Partecipazione / Beteiligung
Già negli anni Settanta, la ”partecipazione” era una delle rivendicazioni centrali promosse dalle mostre della Biennale come una richiesta di un suo confronto con la realtà politica, sociale e urbanistica di Venezia. Il collettivo d’architettura AKT e l’architetto viennese Hermann Czech partono da questo punto per concepire una riconversione temporanea del padiglione a luogo d’incontro con il tessuto urbano circostante. Così, il padiglione simmetrico, disegnato da Josef Hoffman, viene diviso in due. La metà occidentale rimane accessibile provenendo dalla Biennale, la metà orientale dell’edificio, cortile compreso, dovrebbe essere liberamente accessibile a partire dalla città, attraverso un accesso appositamente realizzato con un ponte. Il progetto non è stato però approvato e l’intenzione rimane simboleggiata dalla costruzione interrotta del collegamento.

Bahrain: Sweating Assets
Il padiglione esplora le condizioni climatiche uniche di caldo e umidità estremi, insieme alle attuali esigenze di comfort in Bahrain. La mostra va dalla scala domestica a quella territoriale, per evidenziare la potenzialità delle infrastrutture di raffreddamento in relazione a un ecosistema più ampio. Nelle condizioni di calore e umidità del Bahrain, l’aria condizionata produce condensa proporzionalmente elevata che può essere reindirizzata ad alimentare sistemi ecologici privi di acqua. L’installazione consta di un modello in scala di recupero acqua funzionante, che coniuga la correttezza dell’informazione tecnologica con la precisione di un’accurata manifattura.
Brasile: Terra/Earth
Il Brasile affronta il passato per progettare un possibile futuro ponendo la Terra al centro del dibattito. Come da titolo, di terra viene rivestito il suolo, di terra vengono costruiti i basamenti e i supporti necessari per raccontare una vicenda che riporta alla luce attori dimenticati dalla storia architettonica. Si parla del rapporto tra la terra e i territori indigeni, tra “luoghi di origine e archeologia del futuro”. La poetica della terra, il suo colore, il suo odore riempiono il padiglione con immagini, dati, disegni, filmati e fotografie che ci restituiscono un paese complesso e affascinante, riuscendo nell’operazione a tal punto da meritarsi il Leone d’Oro tra le partecipazioni nazionali.

Canada: Not for Sale!
Il collettivo Architects Against Housing Alienation (AAHA) firma il padiglione con un Not for Sale! che è al contempo nome della sede, manifesto e slogan per una “campagna di attivismo architettonico” che si batte contro l’alienazione degli immobili, ma punta il dito anche contro la colonizzazione del paese a discapito dei nativi. Partendo da una grave crisi abitativa che da anni affligge il paese, il team interdisciplinare di architetti e attivisti propone idee e progetti per alloggi migliori dal punto di vista creativo, sociale ed ecologico. Alcuni dei curatori appartengono ad associazioni che rifiutano il concetto di proprietà e le forme di “architettura finanziarizzate” e si battono per un mercato che offra case più sicure, sane, eque e accessibili. Il bel padiglione disegnato dai BBPR nel 1956 viene così “occupato” con un allestimento che prende le forme del sit in di protesta e della sede di un collettivo organizzato.
Cina: Renewal: a symbiotic narrative
Il curatore Ruan Xing ha coinvolto molti professionisti e istituti per un ricco progetto espositivo che si sviluppa attorno a tre capitoli: Density (meraviglia, ritratti di pluralità); Liveability (rinnovamento, storie di Shanghai); Symbiosis (futuro ringiovanimento). La ricerca riguarda le leggi fisiche che determinano le forme in architettura e anche l’antropologia culturale intesa come studio delle relazioni tra esseri umani e il loro habitat, ricercandone significati e confronti attraverso lo studio della tipologia degli edifici. Il programma, ambizioso, richiede una visione concentrata sui molti modelli presentati, di pregevole fattura, ma non d’immediata comprensione se non si conosce appieno il contesto. L’allestimento conta due file parallele di espositori/colonna che scandiscono lo spazio con i due colori luminosi rosso e bianco e suggerisce una passeggiata architettonica attraente.

Egitto: NiLab – Il Nilo come laboratorio
Uno dei fiumi che più ha influito sullo sviluppo delle civiltà antiche è oggi una grande piattaforma di riflessione sul tema dell’acqua nel contesto più generale dei cambiamenti climatici per l’elaborazione di idee e progetti: un laboratorio per la conoscenza. Curato dalla Facoltà d’ingegneria dell’Università Ain-Shams del Cairo, con il Dipartimento Architettura e Territorio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il padiglione restituisce con grafica, proiezioni e un grande modello, la storia d’interventi che non hanno saputo interpretare l’ambiente e le culture del luogo, che hanno modificato profondamente il paesaggio, creando danni irreparabili e costringendo migliaia di persone a cambiare i loro millenari stili di vita e le pratiche agricole. La conoscenza è anche la base per innescare una nuova progettualità.

Estonia: Home Stage
Un simpatico appartamento sul canale (Castello 96) che costeggia l’Arsenale diventa il padiglione estone, che esplora la contraddizione tra lo spazio abitabile inteso come casa e come valore di scambio grazie a una durational performance, in cui le mansioni domestiche e i dialoghi si svolgono di fronte al pubblico. L’attenzione si pone “sull’ampia visibilità del settore immobiliare che, soprattutto a Venezia, è guidato dall’iper-turismo e dalla gentrificazione”. Iniziativa simpatica e coinvolgente che però, come tutte le performance, ha difficoltà a sostenere un evento di lunga durata come la Biennale e a raggiungere un numero significativo di persone.
Grecia: Bodies of Water
Bodies of Water sono le dighe e bacini idrici che hanno trasformato il paese, per sua natura arido, a partire dagli anni ’30, tramite un ampio programma di captazione e ritenzione dell’acqua volto a provvedere l’irrigazione, l’approvvigionamento idrico e la produzione di energia. Un numero considerevole di laghi artificiali costituisce un vasto arcipelago interno che contrasta con l’immagine comune della Grecia paese di mare con un interno arido e accidentato. I corpi idrici, le dighe e i terrapieni, costituiscono un’architettura pubblica, della polis, che trasforma la terra in χώρα, cioè paese, inteso sia nel senso di territorio, sia come luogo che contiene la vita dei suoi abitanti. Anche in questo caso si tratta di un padiglione che narra un passato che era futuro e ora costituisce il presente su cui costruire un nuovo progetto pubblico di emancipazione collettiva e progresso. L’allestimento è risolto con eleganza tramite modelli in cartone ondulato, piani sospesi in vetro serigrafato, un regesto collocato alle pareti con grafica discreta e sicura.
Israele: Cloud-to-ground
Il padiglione murato costringe a percorrerne il perimetro in cerca di un accesso. Si giunge così al patio retrostante dove alcuni eleganti modelli in microcemento fanno mostra di sé. La mostra esamina il passaggio dalla comunicazione analogica a quella digitale, simboleggiata dalla transizione da edifici tecnologici inaccessibili collocati nei centri urbani a strutture altrettanto inaccessibili, ma collocate in territori periferici e privi di un disegno urbano. Si invita a riflettere sul ruolo che l’architettura gioca nel definire “l’hardware della quarta rivoluzione industriale”, cioè l’ossatura del sistema delle moderne comunicazioni. La mostra mette in luce i processi economici e geopolitici attualmente in corso in Israele e nei paesi limitrofi con l’eleganza espressiva e l’efficacia di un allestimento che coinvolge, negandola, l’architettura del padiglione.

Kuwait: Rethinking Rethinking Kuwait
Partendo dalla presa d’atto della cancellazione della maggior parte del tessuto edilizio storico di Kuwait City, il padiglione, collocato negli affascinanti spazi dei Magazzini del sale, propone nuovi metodi di progettazione architettonica e urbana che provano a sovrapporre i concetti di spazio e tempo in un’ottica di decolonizzazione e decarbonizzazione che porta a ripensare l’utilizzo dei mezzi di trasporto in città e la sua accessibilità al fine di riparare i “guasti” della modernità. Il progetto prende le mosse dalla città per guardare al Kuwait su scala nazionale e presenta studi effettuati da giovani progettisti che esplorano gli spazi di transizione della città che variano per portata e scala. Il gruppo curatoriale ha immaginato la storia come una spirale piuttosto che come un segmento del tempo lineare, concretizzando l’idea in un allestimento di tessuti bianchi che fluttuano nello spazio, offrendo la superficie per l’esposizione di eleganti disegni che ci dimostrano come le buone pratiche del passato possano influenzare il futuro sviluppo della società.
Lettonia: T/C LATVIJA (TCL)
“506 prodotti unici che si ispirano alle ultime dieci mostre di architettura, creati dagli autori con l’aiuto dell’intelligenza artificiale”. Questo il payoff di un padiglione che, a vent’anni dalla sua prima partecipazione, porta la Lettonia alla ribalta per la freschezza e la riuscita della proposta. I prodotti sugli scaffali sono sagomette di cartone che personificano i vari paesi nelle ultime edizioni, rappresentate con tanto di titolo e logo. Allo spettatore viene data una pallina antistress e il compito di scegliere i tre prodotti/paesi preferiti e, di conseguenza, imbucare con un plastico lancio la pallina nell’apposita bocca predisposta sulla sommità degli scaffali. Più facile a dirsi che a farsi, il pubblico verrà poi premiato con uno scontrino che riporta le preferenze espresse, mentre la pallina si raccoglierà ai piedi di ogni edizione e, fra sei mesi, permetterà di stendere una classifica che nessuno, neanche i curatori, sa bene a cosa porterà.

Messico: Infraestructura utópica: la cancha de básquetbol campesina / Utopian Infrastructure: The Campesino Basketball Court
Un’infrastruttura utopistica, il campo da basket campesino: il titolo propone un campo da basket reale, si può giocare e sfidarsi, che è anche un laboratorio di ricerca, mettendo in evidenza uno spazio temporaneo creato per socializzare per fare sport, discutere, lavorare, e che connette ambienti urbani e rurali. L’installazione ripropone il tema dell’equità sociale, andando al di là della semplice “decostruzione” di una struttura sportiva occidentale, per diventare “il punto di partenza per la costruzione di una cultura indigena della resistenza”.

Stati Uniti d’America: Everlasting Plastics
Installazioni site specific che esplorano l’universo della plastica. I polimeri esordiscono nel secolo scorso come materiali rivoluzionari, economici, durevoli e dalle forme infinite, per arrivare oggi alla sovrapproduzione allarmante che sfiora la calamità globale. Questa la motivazione che spinge architetti, artisti e designer a concentrarsi sull’esame e sul recupero della sovrabbondanza dei detriti plastici che c’invadono. Ne nascono nuovi materiali secondi che vengono presentati in una sorta di magazzino visitabile, anche se rimane da chiarire esattamente il quadro nel quale se ne propone l’utilizzo.
Taiwan: Architecture as On-going Details Within Landscape
14 tipologie climatiche si dispongono lungo i 100 chilometri che costituiscono la sezione di Taiwan dalla costa marittima alla montagna di Giada, la cima più alta di Taiwan, è possibile attraversare ben, che su scala mondiale sarebbero normalmente distribuite su una superficie di 10mila chilometri, ma gli alti edifici si affastellano nelle città senza aver alcun dialogo con questo mondo “naturale”. Proponendo un’esposizione (nel Palazzo delle Prigioni a Castello) che si articola su 4 diversi livelli (corridoio d’ingresso, documentazioni del paesaggio, proiezioni, proposte di progettazioni), il padiglione propone un’architettura che, utilizzando la tecnologia, sia sempre più in grado di affrontare il futuro facendo tesoro delle lezioni del passato. Una lettura attenta e circostanziata che merita approfondimenti.
Ucraina: Before the Future
«Oggi la resistenza ucraina offre, con le sue intrinseche complicazioni, nuovi e diversi concetti di futuro, le cui forme sono disegnate dalle azioni quotidiane di tutti i soggetti coinvolti. Questa visione si basa sulla cooperazione tra auto-organizzazione, contributo personale e costruzione dello Stato. Questo futuro, per cui vale la pena combattere, è aperto alla sincera collaborazione di oggi». Questa la dichiarazione di intenti dei tre curatori della partecipazione ucraina, che si declina all’Arsenale in uno spazio claustrofobico, senza luce diretta, ove un telo scuro copre ogni cosa, simboleggiando luoghi abbandonati che possono diventare spazi vitali per progettare piani di speranza per il futuro. L’installazione a cielo aperto presso lo Spazio esedra ai Giardini cita «Una rete di fortificazioni del X secolo nella regione di Kiev in gran parte dimenticata, che è stata riattivata durante i primi giorni dell’invasione russa, riuscendo a rallentare l’avanzata dell’esercito invasore verso la capitale».

Nato a Milano (1963), dove si laurea in architettura al Politecnico nel 1987. Nel 1989 inizia il sodalizio con Pierluigi Cerri presso la Gregotti Associati International. Nel 1991 vince il Major of Osaka City Prize con il progetto: “Terra: istruzioni per l’uso”. Con Bruno Morassutti partecipa a concorsi internazionali di architettura ove ottiene riconoscimenti. Nel 1998 è socio fondatore dello Studio Cerri & Associati, di Terra e di Studio Cerri Associati Engineering. Nel 2004 vince il concorso internazionale per il restauro e la trasformazione della Villa Reale di Monza e il Compasso d’oro per il sistema di tavoli da ufficio Naòs System, Unifor. È docente a contratto presso il Politecnico di Milano e presso il Master in Exhibition Design IDEA, di cui è membro del board. Su incarico del Politecnico di Milano cura il progetto per il Coffee Cluster presso l’Expo 2015