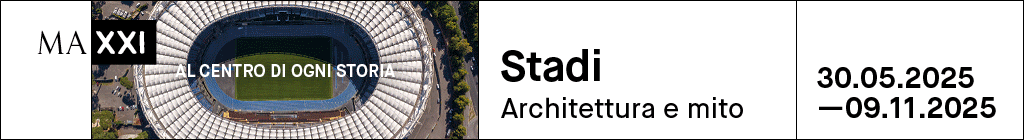Arabia Saudita, Emirati Arabi, Perù, Uruguay
Tra implementazione tecnologica della tradizione e interrogativi sull’architettura
Published 23 maggio 2023 – © riproduzione riservata
Arabia Saudita: Irth ارث
Emirati Arabi e Arabia Saudita si allineano in un itinerario comune. Prossimi nella geografia, prossimi nell’esposizione, prossimi anche nell’area tematica. Il Laboratorio del futuro, in ambo i casi, prende le mosse dal passato e si pone all’insegna dell’innovazione nella tradizione (ma non sappiamo se sia la direzione giusta). Considerate le relazioni tra patrimoni culturali immateriali e ricadute materiali, l’Arabia Saudita considera l’argilla come ancestrale materiale di costruzione e affida la produzione dei manufatti, invece che agli stampi e al calore dei forni o del sole, alle stampanti 3d. L’antichissimo materiale fluido viene così colato e stratificato da stampanti a controllo digitale a confezionare una nuova tipologia di simil-tegole che i visitatori potranno assemblare sulle colonne di questo tempio anfiprostilo in cui si articola l’esposizione minimale. Al centro della cella, unico oggetto presente, un rocchio di colonna gettata dalla consueta stampante 3D, questa volta in materiali sabbiosi, illuminato dall’interno come un tabernacolo che tuttavia è pensato per essere replicato in altri esemplari che andranno a occupare gradualmente lo spazio centrale e buio del padiglione nei mesi della mostra. Altrettanto sono destinate ad aumentare di numero e quindi a essere replicate le pseudo-tegole che rivestiranno le colonne d’ingresso: viene allora da chiedersi se . fatta salva l’interessante sperimentazione – la stampante 3d sia lo strumento più idoneo alla riproduzione, oppure resti l’antico processo di forma ed essiccazione il metodo più efficiente e sostenibile alla necessaria replicabilità degli elementi base del costruire.

La Biennale di Venezia, 2023. @venicedocumentationproject
Courtesy of Ministry of Culture
Emirati Arabi: Aridly Abundant
Sull’altro lato delle Sale d’armi, gli Emirati Arabi navigano in qualche modo sulla medesima rotta: implementare la tradizione della costruzione vernacolare con oggetti della produzione contemporanea esito di raffinate stampanti 3d. Il catalogo della mostra è un interessante volume sull’evoluzione che il progressivo giungere di nuovi materiali e tecnologie ha determinato sulle forme del costruito in ambienti extra-aridi (In Plain Sight: scenes from aridly abundant landscapes, a cura di Faysal Tabbarah and Meitha Almazrooei, ed. La Biennale di Venezia, 2023). Le tecniche tradizionali di demarcazione di proprietà e campi, di recinzione, irrigazione, costruzione, si sono sempre dimostrate ospitali e inclusive di nuove tecniche e materiali, per quanto essi potessero giungere frammentati e scarsi nei contesti periferici e aridi dei monti Hajar. Così, i sistemi d’irrigazione hanno visto le canalizzazioni tradizionali implementarsi senz’essere sostituite dalle perforazioni e dai pozzi. Altrettanto accade per le recinzioni, dove nuove reti metalliche s’integrano agli antichi recinti di pietra senza soluzione di continuità, secondo un accostamento ingenuo volto evidentemente a prediligere lo scopo sull’estetica e la coerenza materica. Nel padiglione, all’ingenuità si sostituiscono il calcolo e la tecnologia avanzata. I muri a secco, stratificazione del disponibile, vengono a essere implementati di “stampelle” o sostegni in plastica o alluminio, forgiati appositamente per stare tra una pietra e l’altra in un muro che, prima di essere eretto dal vivo, è stato costruito virtualmente a partire dalla digitalizzazione degli elementi disponibili per costruirlo. Minima negli esiti, e dunque formalmente e quantitativamente consimile agli esempi storicizzati, l’operazione è però massima nello sfruttamento tecnologico che, lasciateci dire, non si saprebbe poi come rendere autoctono, se non contando su pannelli solari a dotare di energia elettrica computer e stampanti 3d che, a quel punto, potrebbero utilizzare sabbia e aggregati del contesto locale piuttosto che importare plastica e alluminio da chissà dove. E forse l’uso ingenuo di materiali allogeni era più intuitivo, immediato e naturale di quest’implementazione che più che artificiale pare artificiosa.
Perù: Walkers in Amazonia. The Calendar Project
Sulla foresta si concentra invece il Perù, ma qui si tratta dell’ampio territorio vergine della porzione peruviana di una delle più grandi riserve d’ossigeno del pianeta: l’Amazzonia. La mostra, al primo piano delle Sale d’armi, merita una visita. Offre un catalogo abitabile tra i segni sensibili di un lungo percorso con 44 comunità indigene di cultura Kichwa (32 comunità), Shawi (9), Awajún (3). Il catalogo è l’antologia ampia e dettagliata del progredire di un prolungato percorso partecipativo. All’annosa questione su che cosa sia l’architettura, la risposta che s’intuisce dalla tenda di quest’esposizione è la capacità dell’arte di permettere l’abitare, particolarmente il risiedere, sebbene i suoi strumenti non si possano esaurire nella pratica del costruire. Anzi, se l’architettura è quell’arte che mediante lo spazio controlla il tempo, qui accade il contrario; e l’ampio percorso partecipativo mira a dotare le comunità di uno strumento che, promuovendo una competenza sul tempo, porti in realtà a controllare lo spazio, rafforzando le popolazioni rispetto al risiedere, al permanere. È del resto un criterio già acquisito: la tutela dei contesti più fragili, dei patrimoni immateriali, degli equilibri ambientali, passa per la permanenza di una tradizione, ossia per la coerente evoluzione di una comunità residente e indigena, ove questa sia ancora presente. Lo strumento che l’associazione Waman Wasa ha evoluto relativamente a questi scopi, già vent’anni fa, in esperienze con comunità andine, è un calendario partecipativo che si costruisce con la comunità e che le si consegna come una sintesi del loro essere-nel-tempo e, di qui, del loro essere-nel-mondo. Il risultato è un prodotto grafico naif, che pone al centro il villaggio e sovrappone mese per mese le attività che si svolgono nei diversi layers in cui si articola la vita comunitaria: la casa, l’orto, il bosco e il paesaggio. Il tempo, nella sua ciclicità, regola lo stare insieme di questi aspetti, che ciascuna comunità descrive come esito di un proprio processo di autocoscienza.
Uruguay: En Ópera. Escenarios futuros de una joven Ley Forestal
Il padiglione rinnova il tema dell’allegoria dell’architettura. La nostra Arte si personifica nella figura di una donna fluida, robotizzata, trafitta da uno pneumatico che canta il suo disagio esistenziale: Chi sono? Quali sono i miei confini? Domande che echeggiano, esplicite o implicite, in tutti i padiglioni della Biennale senza trovare un contenitore ad assorbirle o a risponderle. Questa si compone forse oltre l’esposizione, nel viaggio che ti sottrae alla kermesse e ti riporta ai territori dietro casa che t’interpellano con i consueti problemi, e reclamano soluzioni. Alla Biennale il problema dell’architettura è la sua stessa autocoscienza, che nel padiglione dell’Uruguay diventa canto, immagine e consapevolezza, risolvendosi però in audiovisivo. Il padiglione è la sede di un’opera che attiene al territorio delle arti visive e che dà da voce a uno dei temi più controversi che innestano il paese nella macchina della globalizzazione. Anche in questo caso la denuncia apre a una domanda senza risposta: quale ruolo per l’architettura negli accelerati processi di produzione e distruzione legati al consumo globale? Il tema impatta il piccolo paese per una tra le più grandi produzioni al mondo di cellulosa da carta, esito della lavorazione di una foresta a crescita rapida (eucalipti e abeti) che crea ecosistemi effimeri, ciclicamente abbattuti e reimpiantati a danno delle originarie e vaste praterie. Il legno poi si fa truciolo e lascia il paese che di tutto questo processo non conserva neppure un frammento, se non il danno di una radicale trasformazione del paesaggio. Ma la legge sulla forestazione, che il padiglione denuncia chiamandola giovane, è in realtà del 1987, già forse pronta per essere presentata a qualche Biennale passata, prima che la piantagione diventasse foresta.

Nato a Bologna (1977), vi si laurea in Ingegneria edile nel 2003. È ricercatore presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna, ove nel 2008 ha conseguito il dottorato di ricerca in Composizione architettonica. Si occupa specialmente dei rapporti tra sacro e architettura, in collaborazioni formalizzate con la Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna ove è professore invitato per seminari attinenti alle relazioni tra liturgia, paesaggio e architettura. Presso la Scuola di Ingegneria e Architettura di Bologna insegna Composizione architettonica e urbana, ed è stato docente di Architettura del paesaggio e delle infrastrutture. È collaboratore de “Il Giornale dell’Architettura” e direttore della rivista scientifica del Dipartimento, “in_bo. Ricerche e progetti per il Territorio, la Città, l’Architettura”