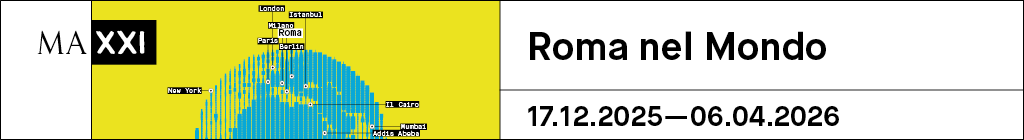Svizzera vs Venezuela: Neighbours
Un varco nel muro e via il cancello tra i padiglioni di Bruno Giacometti e Carlo Scarpa
Published 23 maggio 2023 – © riproduzione riservata
Questa è la storia di due padiglioni attigui e coetanei – condizione unica nei Giardini della Biennale – quello svizzero, disegnato da Bruno Giacometti (1952-54) e quello venezuelano, progettato da Carlo Scarpa (1954-56). Se la Svizzera, federalista, gode di una stabilità economica che si riflette anche nel padiglione, minimalista e intatto, il Venezuela, anch’esso federalista, è segnato da forti crisi politiche, economiche e sociali, ripercosse anche sullo stato del padiglione, ricco di dettagli ma vittima di abbandono e di modifiche del progetto scarpiano originale. È innanzitutto la storia di un’amicizia, quella fra Scarpa e Giacometti, e di due modi di fare architettura diversi, che s’incontrano realizzando un vincolo sentimentale.
Un muro li unisce, un muro e un cancello li divide. Nel muro di mattoni è stato aperto un varco e il cancello di ferro è stato rimosso, affinché lo spazio sia continuo. L’idea svizzera viene accolta dal Venezuela, che pure mette in mostra, a cura di Paola Claudia Posani e Henrique Vera, il restauro della città universitaria di Caracas, opera dell’architetto Carlos Raul Villanueva e patrimonio Unesco dal 2000.
La Svizzera esibisce se stessa e apre un dialogo coi vicini abbattendo le frontiere. Su orae, confini in latino, la Svizzera si era già espressa nella Biennale scorsa, con la mostra omonima, presentando un progetto territoriale che raccoglieva esperienze collettive vissute lungo i vari luoghi di confine che circondano il suo suolo. Se nel 2021 i confini svizzeri venivano evidenziati, nella Biennale 2023 sono negati in nome di un dialogo tra Paesi, tra arte e architettura, tra relazioni materiali e spaziali che prendono una forma altra. Le pareti, i tetti e le aree esterne dei due padiglioni si incontrano, secondo l’idea degli autori, l’artista Karin Sander e lo storico dell’arte Philip Ursprung, entrambi docenti al Politecnico di Zurigo, tramite l’annullamento utopico di ogni forma di competizione fra i padiglioni nazionali, e dunque attraverso un ampliamento degli orizzonti grazie a relazioni interpersonali e internazionali. Il legame fisico tra i due padiglioni, e anche tra l’arte e l’architettura, è rappresentato da un tappeto che si trova nella sala principale, come un foglio da disegno bianco srotolato, su cui sono state tracciate in nero le planimetrie dei due edifici limitrofi.
I progetti dei due padiglioni sono stati disegnati includendo nei lotti gli alberi preesistenti e protetti accanto ai filari di platani secolari lungo il viale dei giardini, come si può leggere nelle piante esecutive stampate sul tappeto. Questi alberi per decenni sono stati parte del padiglione, lo hanno protetto e adombrato, fino alla morte, lo scorso anno, di quello sito nel cortile. I curatori ne vogliono sottolineare l’importanza lasciando la traccia del tronco segato, finché non sarà sostituito con una nuova pianta. Gli alberi rinfrescano anche il padiglione del Venezuela, paese tropicale, e il progetto di Scarpa, pieno di luce e aperture, è concepito come se fosse collocato in questo clima.
L’obiettivo del Venezuela è di presentare, nel 2025, dopo il recupero della città universitaria di Caracas, quello completo del padiglione scarpiano in tutto il suo valore, e in questo senso le opere di Scarpa, Villanueva e Giacometti si ritrovano, come in un convivio fra grandi architetti della modernità.
Insegna all’ULB e al Politecnico di Bruxelles, e all’EPFL di Losanna. Si è laureata in architettura a Venezia (IUAV), poi specializzata all’Ecole normale supérieure di Cachan-Parigi. È dottore di ricerca in Storia delle scienze e delle tecniche costruttive, ha frequentato il master in Ponti dell’ENPC di Parigi, sempre sostenuta da solide fondamenta umanistiche, preziosa eredità della formazione liceale classica. Ha insegnato presso le Università di Architettura di Venezia, Losanna, Mendrisio. Per 10 anni è stata redattrice della rivista svizzera “Archi”, e collabora tra gli altri con “Tracés” e “il Corriere del Ticino”. Ha vinto per due anni consecutivi il Premio giovani ricercatori del Murst. A Venezia ha restaurato – primo esempio al mondo – un ponte in ghisa storico con fibre aramidiche (AFRP). I suoi ambiti di ricerca sono, oltre alla meccanica della frattura dei materiali fragili e il restauro con i materiali compositi, la storia dei materiali, dell’ingegneria e delle tecniche costruttive. Ha compartecipato alla 14. Mostra internazionale di architettura di Venezia con l’evento collaterale: „Gotthard Landscape-the unexpected view“. Ha curato mostre di architettura e strutture a Venezia, Torino e Ginevra. È stata direttrice responsabile della Fondazione Wilmotte di Venezia; perito tecnico d’ufficio del Tribunale civile di Venezia; membro attivo di varie associazioni di ingegneria, per l’arte e la storia dell’ingegneria, è autrice di numerose pubblicazioni. Collabora con la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti