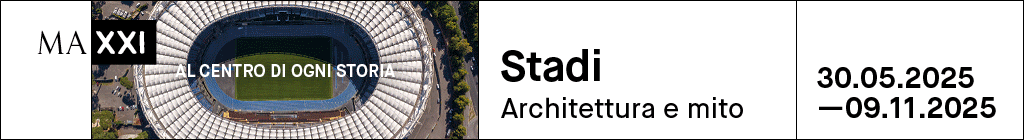Una questione di generosità e di ibridazioni
Dal tempo all’ibridazione. Un glossario per l’innovazione del progetto pubblico
LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DELLO SPECIALE
Published 6 maggio 2025 – © riproduzione riservata
Se è vero che la trasformazione e la ri-funzionalizzazione delle proprietà pubbliche sono forse le uniche occasioni per interventi potenzialmente capaci di incidere e aggiornare realmente il tessuto urbano, è altrettanto vero che individuare delle linee efficaci per ridestinare l’uso, costruire un dialogo efficace con l’amministrazione pubblica e trovare un equilibro economico dipende da una visione in grado di amplificare le “prime” necessità (abitare, studiare, lavorare e stare bene) e di armonizzarle con lo scenario futuro.
Le città italiane, oggi, non sono adeguate alla società contemporanea. Questo stato diacronico e la divergenza storica tra spazio urbano, architettura e persone, non consente di prefigurare un futuro aggiornato, a fronte dell’accelerazione del cambiamento.
Grande limite e opportunità insieme dei processi di trasformazione urbana è il tempo: limite perché si interviene su oggetti nati e ancorati ad abitudini e comportamenti sociali del passato con l’obiettivo (peraltro già molto complesso) di attualizzarli al presente e opportunità perché l’azione si può e deve spingere verso una visione estesa al futuro prossimo e remoto.
L’invocata interdisciplinarietà si deve alimentare non solo alle competenze affini all’architettura ma, ancora di più, alla sociologia, alla demografia, alle previsioni d’uso della tecnologia diffusa. I contributi interdisciplinari devono essere bilanciati in disegni armonici che tengano insieme tutte le componenti, non il solo innesco voluto o richiesto per qualche singola emergenza.
Rigenerazione urbana, mobilità dolce, sostenibilità energetica e ambientale: i percorsi tracciati che sono oggi i riferimenti progettuali, in parte sperimentati e normati, sono assolutamente necessari, ma fanno già parte di un base concettuale e operativa che dovrebbe costituire zoccolo duro per i nuovi orizzonti del cambiamento che essi stessi contribuiscono a generare. Allo stesso tempo occorre dire che, nella maggior parte dei casi, i temi della rigenerazione non sono diventati politiche urbane; più spesso si limitano a essere slogan, dichiarazioni lontane dalla complessità della realtà e dalla volontà di attivare le azioni necessarie per la trasformazione.
La riqualificazione energetica
Usando un’espressione cara al giornalismo d’epoca, negli ultimi anni, nei progetti di riqualificazione del patrimonio pubblico, l’aspetto energetico è stato “sotto i riflettori” più della visione generale della sua trasformazione. Secondo un recente studio della Fondazione Ambrosetti, il 56% degli edifici pubblici non è energeticamente efficiente, cioè sta nelle classi energetiche più basse.
Il patrimonio censito conta 1 milione e 150 mila fabbricati. In linea con la direttiva UE, il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec) prevede ora un obiettivo di efficientamento del 3% annuo del patrimonio edilizio pubblico dal 2025 al 2030, target 9 volte superiore alla superficie riqualificata tra il 2014 e il 2022. Si tratta, dunque, di un problema reale.
È però sostanziale non confondere l’attenzione sul manufatto edilizio, che è più semplice da normare con prassi e regole virtuose, con gli aspetti tecnico-economici, e ancor più architettonici, urbani e di paesaggio. Se è urgente raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione imposti dall’UE per gli edifici pubblici, ed è un passaggio cruciale per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, è altrettanto fondamentale considerare le mutazioni sociali e dei comportamenti, in relazione alle destinazioni d’uso.
Il senso vero della rigenerazione
L’architettura possiede un’inclinazione a “dare/donare”. Si tratta di un valore intrinseco alla sua funzione: dà alloggi, scuole, uffici, piazze, musei, ospedali in cui ogni singola persona e le persone nel loro insieme possano vivere bene. Una sorta di istinto professionale dovrebbe guidare l’architetto a “dare/donare”, ma negli ultimi decenni la mancanza di una responsabilità professionale collettiva ha condotto, invece, a togliere spazio, soprattutto per la condivisione, per l’accoglienza, per l’integrazione.
Le committenze private e pubbliche hanno suggerito/imposto l’avarizia sulle dimensioni, sui materiali, sulla luce, sulla narrazione e sull’accoglienza psicologica ed emotiva degli edifici, e gli architetti ne hanno fatto, spesso, regola di progetto. Per comprenderlo è sufficiente guardare il costruito diffuso, le periferie soprattutto, ma anche le fasce di transizione, i modelli di mobilità delle grandi e delle medie città.
Se è vero che siamo in una fase di ripensamento, il patrimonio pubblico da trasformare rappresenta una straordinaria opportunità. Ma non ha senso che l’esigenza di adeguarsi a paradigmi diversi si sviluppi replicando le logiche della prima fase di declamazione della sostenibilità ambientale, per necessità di mercato, di consenso elettorale, di comunicazione.
Pensiamo, da sempre, che la generosità sia la chiave di volta dell’architettura contemporanea. Non una generosità che si esprime solo sulla qualità del costruito o sui metri quadri, ma su un’intensa partecipazione alla vita e alle attività delle persone, facendo del buon vivere l’obiettivo, ma ancora più importante, la normalità del progettare.
Mettere insieme architettura e generosità significa assumere riferimenti diversi, mostrando il coraggio di contaminarsi con la realtà sociale, urbana, con la rivoluzione in essere che sta mettendo in dubbio persino le comfort zone progettuali più consolidate: l’abitare che diventa nomade, la scuola hub sociale, gli ospedali che dovranno assomigliare sempre meno a ospedali, l’arte che si diffonderà per le strade e le piazze.
Non è la prefigurazione di un’utopia, né un mero esercizio rappresentativo da qui ai prossimi 50 anni. È semplicemente prendere atto di una molteplicità di processi in corso che porteranno a una dimensione diversa di vita futura. La generosità progettuale sta in questo processo che è prima cognitivo e poi professionale: disancorarsi da quello che è più semplice e comodo e conosciuto, faticare per trovare nuove formule. Ed è su questi presupposti che si deve fondare il processo di innovazione del patrimonio pubblico.
È fondamentale sia correggere le deformazioni, ribilanciando i temi dell’accoglienza, della casa e dei servizi, sia ridisegnare spazi sincronizzati sulla mutazione continua, senza creare distorsioni, né lasciare inevase le emergenze, agevolando l’interazione con le riflessioni contemporanea e con i dispositivi di potenziamento che la tecnologia consente, proiettandoli verso il futuro della gen beta e delle successive
Mixitè etnica, identità sessuale, inter-generazionalità e utenze fragili, contaminazione crescente tra immateriale / digitale e fisico sono i nodi sensibili sui quali è necessario e urgente intervenire con gli strumenti del progetto d’architettura finalizzati a costruire una città buona, cioè capace di assicurare ai propri cittadini un benessere democratico. Significa, in concreto, che tutti gli insiemi delle persone, particolarmente nella dimensione pubblica e del patrimonio pubblico, devono essere rappresentati e avere spazi nelle città piccole, medie, metropolitane.
Dunque, anche la mono-funzionalità deve lasciare spazio all’ibridazione. Lo sforzo dovrebbe essere quello di risolvere la segregazione, agevolando la conoscenza dei differenti stili di vita e di comportamento e, attraverso la mixitè, in un senso molto più ampio e articolato, mitigare i conflitti.
Tecnologia e memoria
Non da ultimo, quello che si trasforma ora è destinato alle generazioni future. Qui lo sforzo di immaginazione è enorme, esce dal perimetro dell’architettura fisica tout court, per orientarsi nella ricerca di percorsi di esplorazione dell’immateriale futuro – la dimensione digitale – con l’immateriale del passato, la storia non scritta, non testimoniata da oggetti e vestigia che per essere conservata ha bisogno della tecnologia.
È una sfida enorme quella di sviluppare un ragionamento progettuale che sostenga un’architettura ibrida non solo per funzioni, ma anche per la condivisione tra materiale e digitale e dedicata a contenere l’isolamento individuale che i tech devices inducono.
Tornando all’oggetto proposto in questo Speciale, se è vero sicuramente che sono poco utilizzate le partnership pubblico-privato, se l’occasionalità degli investimenti non contribuisce a sviluppare una pianificazione complessiva, la comunità progettuale ha il dovere e la responsabilità, almeno in sede di dibattito e riflessione, di trasferire una visione progettuale allargata, contaminata, senza retaggi anacronistici.
E considerare il tempo come dimensione che scansisce le azioni: il tempo del dialogo e il tempo del progetto che procedono insieme, nutrendosi della rete di connessioni interdisciplinari, scelta responsabile di ogni presente.
Immagine copertina: Forte San Pietro ex Macelli, masterplan strategico per il piano operativo del Comune di Livorno @ Atelier(s) Alfonso Femia
Architetto, designer e urbanista opera professionalmente, in ambito internazionale, dal 1995; è fondatore e presidente di Atelier(s) Alfonso Femia. E’ co-fondatore di 500×100 società benefit attraverso la quale sviluppa i progetti culturali e le attività di ricerca. Nel 2022 il Museo Novecento di Firenze gli ha dedicato una mostra personale ed è stato direttore della III edizione della Biennale Internazionale di Architettura di Pisa nel 2019. E’ ideatore e curatore de La Biennale dello Stretto, che si è svolta per due edizioni nel 2022 e nel 2024. Ha pubblicato numerosi saggi sui temi della città e dell’architettura ed è speaker in conferenze accademiche internazionali. Ha vinto premi in Italia e in Francia, tra i quali l’International Architecture Award “The Chicago Athenaeum”; il BLT Built Design Awards; la Pyramides d’Argent; l’ULI Global Awards for Excellence. È stato incaricato Ambasciatore del Design Italiano da Adi (Associazione Disegno Industriale) a Parigi, Bruxelles, in Uzbekistan, per il 2023 a Jeddah e Riyad e per il 2024 a Miami.