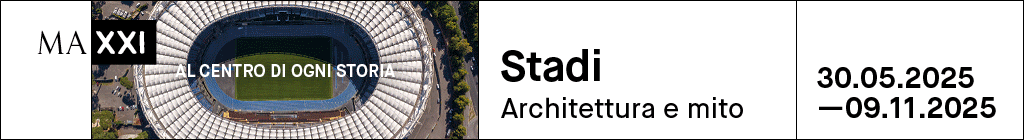Una storia di rottura e di rinnovamento
Riflessione critica e apertura tematica dei curatori del convegno internazionale sul patrimonio
LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DELLO SPECIALE
Published 30 aprile 2025 – © riproduzione riservata
Quando ci imbattiamo in uno spazio pubblico dismesso, abbandonato o vicino al collasso strutturale, stiamo osservando il segno tangibile di un trauma storico, economico e sociale che ha reso quel luogo obsoleto, non più rispondente ai tempi.
In continua evoluzione
Questi spazi, segnati profondamente dal tempo, raccontano storie di un’interruzione, di un distacco, di una lacerazione tra la loro struttura e le dinamiche socioeconomiche della città che continua a evolversi attorno a loro, lasciando sovente che diventino trasparenti, invisibili agli occhi dei cittadini che si abituano semplicemente a girarvi intorno.
Queste lacerazioni del tessuto urbano hanno cause molteplici, talvolta tutte locali, tal altra ricaduta di fenomeni globali, e sollevano questioni profonde sulla capacità delle comunità urbane di rigenerare il proprio ambiente. In un momento storico che pone un’enfasi crescente sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, recuperare questi luoghi significa innescare processi complessi e multidisciplinari, partendo dall’analisi della loro ossatura – le strutture, la tecnica costruttiva, l’efficienza energetica e la qualità architettonica – fino ad immaginarne una nuova vita attraverso una comprensione profonda del tessuto urbano e delle voci della comunità locale.
Le persone non solo conservano la memoria storica, ma comprendono intimamente l’anima dei luoghi facendone parte essi stessi. Tutto questo patrimonio costruito non può essere lasciato fuori da questi percorsi, e dalla vita delle città.
L’architetto ticinese Luigi Snozzi scriveva: “l’architettura nasce dai bisogni reali, ma essa va al di là di essi; se vuoi scoprirla, guarda le rovine”. Un richiamo alle dinamiche mutevoli che gli immobili assumono col tempo, dove alle funzioni s’associano significati e simbolismi generati dalla storia delle architetture e dei luoghi che le forme stesse contribuiscono a definire.
In quest’ottica gli spazi pubblici mutano producendo nuove immagini di città ed aprendosi alle sue nuove esigenze, portando con sé elementi simbolici come patrimoni immateriali in continua evoluzione.
La misura del tempo
Tra conservare e rigenerare o demolire e ricostruire la scelta è spesso un dilemma. La demolizione implica una cesura drastica, che si scontra con il desiderio di recupero delle risorse in un mondo che guarda con attenzione alla sostenibilità delle azioni. Talvolta è però l’unica scelta praticabile, specialmente quando le strutture sono irrimediabilmente compromesse o hanno un valore culturale e sociale esile in corpo fragile.
Anche in casi di tale evidenza, è comunque fondamentale che ogni decisione nasca da un processo di riflessione approfondita e non sia mai l’esito di un giudizio avventato, anche considerando i costi e gli impatti ambientali ed economici delle demolizioni.
I valori che dovrebbero guidare i processi sono quelli della rigenerazione urbana e della valorizzazione della storia, dell’architettura, del significato e della comprensione culturale e sociale degli spazi, reinterpretandone l’uso attraverso un dialogo critico con il loro passato. Questo approccio non si limita solo a rinnovare lo spazio fisico, ma anche a reinterpretare, attraverso il linguaggio contemporaneo, il tempo stesso che lo ha segnato.
Gli artisti Bianco-Valente hanno provato a dare voce a uno di questi immobili dismessi e dimessi, che ci ammoniscono con il loro degrado.
Nel 2019 una loro installazione “impacchettò” la facciata del Pio Monte della Misericordia sul lungomare di Casamicciola Terme, ad Ischia (nell’immagine di copertina). Gli artisti hanno provato a dilatare la percezione e i segni del tempo stendendo una pellicola di carta nera biodegradabile sulla facciata dell’edificio ed apponendo la scritta “MISURO IL TEMPO”.
Oggi tutta quella impacchettatura è stata erosa, lasciando in vista solo la scritta ammonitrice. L’immobile dal 1973 è in attesa, anche se oggi qualcosa sembra muoversi.
Recuperare, anche temporaneamente
La storia recente ci insegna che il tempo del recupero è stato spesso troppo lungo. Esso si è misurato troppo spesso in decenni, piuttosto che in anni. Ciò si può capire e – forse giustificare – perché negli ultimi decenni si è passati dalla cultura del costruire a quella del riuso, della rigenerazione e del recupero, con numeri rilevanti e crescenti rispetto al passato.
La carenza di una cultura progettuale matura sulla rigenerazione, aggravata dall’assenza di strumenti normativi a supporto di azioni idonee di valorizzazione immobiliare, ha fatto scorrere il tempo in maniera spesso delittuosa, facendo pesare il “costo del non fare”.
Oggi sappiamo bene che il non agire è un costo, abbiamo una normativa che consente di valorizzare gli immobili anche con azioni temporanee; è matura una cultura progettuale che ha piena consapevolezza dell’importanza del recupero, avendone anche gli strumenti per attuarlo al meglio.
Oggi, insomma, paiono cadute tutte le scuse e sono sorti tutti gli strumenti, le tecniche e la cultura progettuale per agire. Eppure vi sono domande alle quali occorre ancora dare risposta per perfezionare i processi.
Domande necessarie
Le aree e i volumi di proprietà pubblica sono spesso una delle ultime occasioni che le città hanno per ripensare sé stesse, per incidere sul proprio profilo, per correggere eventuali deformazioni, ribilanciandosi rispetto ai temi dell’accoglienza, della casa e dei servizi. Ma si tratta di opportunità che le amministrazioni sono davvero in grado di cogliere?
Le procedure concorsuali che sono oggi adottate offrono una garanzia adeguata a ottenere risultati soddisfacenti dal punto di vista urbanistico, sociale e della qualità progettuale oppure si tratta di processi che attendono un rinnovamento?
Sul piano dell’architettura, la trasformazione dei comparti pubblici pare richiedere una evoluzione anche ai criteri con cui è inteso il restauro, la cui teoria, lentamente, sta registrando una cauta evoluzione corrispondente a quella della definizione di patrimonio culturale.
Ma il vincolo, inteso come iter tradizionale di riconoscimento di valori culturali è un processo ancora validante, o necessita l’inclusione/integrazione di nuovi modi di curare il patrimonio insieme alle comunità?
La rigenerazione del patrimonio pubblico non è dunque un compito tecnico o amministrativo, è piuttosto un impegno culturale e politico fondamentale che richiede visione, e condivisione e pertanto un’intensa capacità di dialogo. La solitudine dei promotori, l’occasionalità degli investimenti non sono quasi mai forieri di iniziative di successo che vedono invece migliori garanzie in azioni corali, reali percorsi partecipativi e piani duraturi di sostenibilità economica.
Così il progetto si deve fare carico di una dimensione etica, contribuendo a generare una città contemporanea che sia sostenibile, viva e inclusiva e che restituisca in spazi ed architetture i valori sui quali essa è stata ri-costruita e recuperata.
Silvano Arcamone e Francesca Cremasco sono curatori del convegno internazionale Spazio pubblico in trasformazione: qui il programma
Immagine di copertina: Misuro il tempo, installazione di Bianco Valente, Casamicciola Terme, 2019
È un architetto e dirigente pubblico italiano, attualmente Direttore Regionale Sicilia per l’Agenzia del Demanio, con oltre vent’anni di esperienza nel settore dei lavori pubblici, ha ricoperto ruoli significativi sia negli enti locali che in agenzie statali, sviluppando importanti progetti di rigenerazione urbana tra cui il Parco della Giustizia di Bologna presso l’ex Caserma STAVECO, il Progetto di rigenerazione dell’ex Caserma Perotti di Bologna e la Rigenerazione Urbana dell’ex Chimica Arenella a Palermo. È Ambassador a supporto del progetto internazionale BuildingLife del World Green Building Council (WorldGBC), la più grande rete al mondo che promuove azioni per il raggiungimento degli accordi di Parigi e degli obiettivi globali di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nel settore dell’edilizia e delle costruzioni.