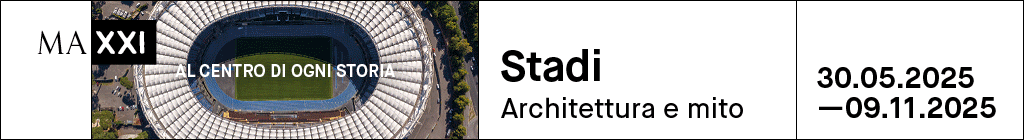Aimi Hamraie: progettare per chi è ai margini
Docente e designer negli USA, colloquio ad ampio raggio su disegno e disabilità
LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DELLO SPECIALE
Published 12 luglio 2025 – © riproduzione riservata
“Realizzo progetti e pianto alberi”. Con queste parole si presenta Aimi Hamraie, figura di interesse internazionale intorno al dibattito su design, architettura e disabilità. In questa intervista, avvenuta attraverso scambi di email, parla di design, tecnologia, formazione e disabilità. E di che cosa si intenda con critical design.
Proviamo a ricostruire in breve la storia e l’evoluzione del discorso intorno all’UD (universal design), dalla sua teorizzazione fino a oggi?
Come spiego nel mio libro “Building Access: Universal Design and the Politics of Disability” (2017), il termine “design universale” fu introdotto per la prima volta dall’architetto disabile Ronald Mace nel 1985. Tuttavia, molte delle affermazioni associate alla progettazione universale (ad esempio, che progettare per la disabilità sia vantaggioso per tutti) sono emerse molto prima, negli anni ’40, ’50 e ’60. A quel tempo, i professionisti della riabilitazione e i responsabili scientifici sostenevano che l’accessibilità fosse importante per favorire l’economia, rendendo le persone con disabilità più capaci di lavorare, e che l’accessibilità avrebbe portato benefici alla popolazione generale, oltre che alle persone con disabilità. Si trattava di una visione molto diversa dal modo in cui la progettazione universale fu successivamente ripresa dagli attivisti per i disabili, che spesso si opponevano alle giustificazioni economiche dei diritti delle persone con disabilità. Successivamente, negli anni ’90, dopo l’approvazione da parte del Congresso degli Stati Uniti dell’Americans with Disabilities Act, l’idea di progettazione universale cambiò ancora. Invece di focalizzarsi su un design che partisse dal beneficio delle persone con disabilità, alcuni progettisti cercarono di ignorare del tutto la disabilità e di passare direttamente al concetto di “universale”. Questa è quella che chiamo una “ideologia post-disabilità”, perché si partiva dal presupposto che la legge avesse risolto il problema dell’abilismo e che i designer non dovessero più prestare attenzione alla disabilità. Nel frattempo, però, questo tipo di progettazione aveva depoliticizzato la disabilità.
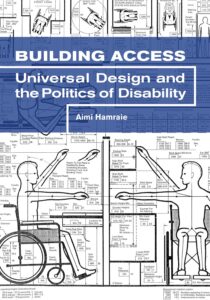
Rispetto all’affermazione “Il design che crea benefici per le persone disabili, porta anche benefici alle persone non disabili”. È corretto dire che quello che funziona per ciascuno, assecondando dei bisogni speciali, può funzionare per tutti, ma non viceversa, cioè che quello che funziona per un tutti generico – spesso coincidente con quell’idea di standard che abbiamo dato sopra – funziona per ciascuno?
L’idea che la progettazione per la disabilità sia vantaggiosa per tutti è molto complessa, e non necessariamente la condivido. Credo che quest’idea abbia assunto significati diversi in momenti diversi, perché il concetto di “tutti” o di “popolazione generale” è cambiato nel tempo. A volte, quando diciamo “tutti”, ci riferiamo alle persone più “normative”, non a quelle ai margini. In realtà, non credo che si debba dare priorità alle persone “normative” nella progettazione. Credo che dovremmo progettare per le persone più emarginate, indipendentemente dal fatto che ciò avvantaggi la maggioranza della popolazione.
Venendo alla questione dei corpi non conformi, non binari, non abili, non ricchi e non occidentali, cioè tutti quelli trascurati dalla progettazione standard, quali ostacoli ci sono, a partire dalla stessa formazione nell’ambito del design, rispetto al considerarli non solo oggetti ma soggetti della progettazione?
L’idea di standard – l’utente bianco, maschio, abile e di classe media – è nata attraverso determinati modi di conoscere e misurare i corpi. Questa figura si è fatta strada nel design attraverso manuali e programmi di studio. Tantissime persone, inclusi designer attivisti, hanno cercato però negli ultimi decenni di introdurre la conoscenza degli utenti non conformi come un modo alternativo per ampliare le tipologie di persone e corpi che i designer possono prendere in considerazione. La formazione nel design include molti aspetti, tra cui il curriculum ufficiale, ma bisogna considerare anche il più ampio discorso sul design, fuori dai programmi di studio universitari. Molte persone intervengono nei discorsi sul design dall’esterno delle scuole di architettura e design. Ad esempio, nel Critical Design Lab, abbiamo un podcast chiamato Contra sui designer disabili e abbiamo anche creato un campus estivo su disabilità e design come spazio alternativo dove gli studenti possono venire a imparare e portare le loro conoscenze con sé nelle scuole di design.
Rispetto agli attivisti o ai movimenti “extra design”…
Non sono a mio agio col termine “extra design”.
Allora mettiamola così: i movimenti per i diritti civili, come detto, hanno spesso favorito la conquista di un allargamento anche sul piano normativo. La mia domanda è se, a volte, ragionare all’interno del perimetro delle norme – e quindi di qualcosa comunque concepito dall’alto che deve convalidare l’esistente – non rischi di indebolire l’effetto più anarchico, lo scarto politico, e anche la quota necessariamente non “normabile” della disabilità.
Ho molte opinioni diverse al riguardo. Da un lato, concordo sul fatto che i diritti non conducano alla liberazione perché il sistema a cui aiutano le persone ad accedere è spesso truccato fin dall’inizio contro le persone emarginate. Allo stesso tempo, la legge non è rigida e immutabile. Cambia, viene modificata e le modalità di applicazione dipendono da decisioni di ogni tipo, che rappresentano ambiti in cui le persone possono intervenire. Almeno negli Stati Uniti, l’Americans With Disabilities Act è stato modificato perché la versione originale non forniva tutele, e gli standard di accessibilità vengono riscritti e ampliati regolarmente. È un processo lento, ma spesso efficace, e un’occasione in cui gli attivisti possono prendere in considerazione l’opportunità di intervenire quando possibile. A volte le alternative a un approccio basato sui diritti pongono un forte accento sul ricorso al libero mercato, che spesso è un luogo ancora più terribile in cui trovare accesso per le persone con disabilità.
A proposito di “luoghi terribili” quando parliamo di accesso al design oggi non ci riferiamo più strettamente al design di prodotto o all’arredo urbano, ma anche alle nuove tecnologie. Per esempio l’IA e la processazione di dati…
L’IA è stata certamente utilizzata per le tecnologie assistive, e potrà essere utile ad altri scopi. Per esempio, l’IA potrebbe tecnicamente aiutare a considerare più tipologie di persone nella progettazione? Certo. Ma l’IA è anche fortemente discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità, come hanno dimostrato molti studiosi. Le risorse destinate al supporto delle infrastrutture di IA, tra l’altro, sono anche dannose per l’ambiente e si basano su processi di estrazione di risorse che producono disabilità, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Quindi dobbiamo tenere conto dell’intera economia politica, al di là della funzione della tecnologia in sé.
Chiudiamo col Critical Design Lab. In che cosa consiste l’approccio al design come strumento critico?
Il termine “critical design” è stato introdotto per descrivere un design che crea un’esperienza alienante per gli utenti, inducendoli poi ad accorgersi e mettere in discussione i propri presupposti o pregiudizi. Come scrivo in Building Access, questo approccio presuppone un utente che non sia già alienato dal suo ambiente. Dato che però molte persone emarginate si trovano ad affrontare barriere di accesso nella progettazione, è più produttivo (a mio parere) affrontare il critical design dalla prospettiva di come la conoscenza emarginata metta in discussione i principi fondamentali del design thinking e della pratica. Nel Critical Design Lab, ci riappropriamo di questo termine per descrivere il design che emerge da persone e comunità con disabilità, in particolare il modo in cui le modalità di conoscenza dal punto di vista della disabilità plasmano il mondo materiale. Tutti i nostri progetti partono da un elemento di design o da un media familiare e propongono un quadro culturale generato dalla disabilità per criticarlo. Lo abbiamo fatto con la mappatura, il podcasting, la curatela di mostre, gli archivi digitali e altri siti di design. Nel nostro progetto Mapping Access, abbiamo invitato persone con disabilità e non a valutare insieme l’accessibilità degli ambienti costruiti, ponendo domande critiche e sollecitando la critica istituzionale. Questo ha reso il progetto diverso da una mappa dell’accessibilità che si limita a coprire codici o standard, perché le persone venivano formate e avevano l’opportunità di interagire criticamente con standard e istituzioni.
Immagine di copertina: diagramma di approccio al progetto, tratto dal sito https://www.criticaldesignlab.com/
![]()
Aimi Hamraie insegna Medicina, Salute e Società e Studi Americani alla Vanderbilt University e dirige del Critical Design Lab. Nel 2017 ha pubblicato “Building Access: Universal Design and the Politics of Disability” (University of Minnesota Press), un libro purtroppo ancora non tradotto in Italia, un libro purtroppo ancora non tradotto in Italia e del podcast Contra su disabilità e design. Sul suo sito scrupolosamente ad alta accessibilità www.aimihamraie.com, oltre a tre diverse biografie a seconda degli usi e tutte le specifiche tecniche espressamente richieste quando viene invitata a parlare a eventi (un manifesto politico del suo lavoro), di sé scrive: “Realizzo progetti e pianto alberi”.
È una saggista, curatrice e divulgatrice culturale italiana che si occupa di cultura materiale, design e storie degli oggetti, indagati come strumenti critici, anche in una prospettiva di genere. Autrice di numerosi saggi sul design italiano contemporaneo e storico, ha pubblicato per editori come Laterza, UTET, Longanesi. Per Electa cura la collana Oilà dedicata a biografie di donne del Novecento che si sono fatte spazio in un universo professionale storicamente maschile. Nota anche per l’ideazione della rubrica social #designinpigiama, nata durante il lockdown del 2020: una serie di racconti quotidiani su oggetti e progetti del passato italiano, che ha attivato una comunità vivace di lettrici e lettori, trasformando la narrazione del design in un processo condiviso e partecipato. Ha collaborato alla produzione di podcast per testate e piattaforme come Il Post, la Repubblica, Archivio Olivetti e Storielibere.fm, contribuendo alla diffusione della cultura progettuale anche nei nuovi formati narrativi. Parallelamente all’attività editoriale e curatoriale, tiene corsi, conferenze e seminari in Italia e all’estero, contribuendo con una voce autonoma e riconoscibile al dibattito contemporaneo sul design.