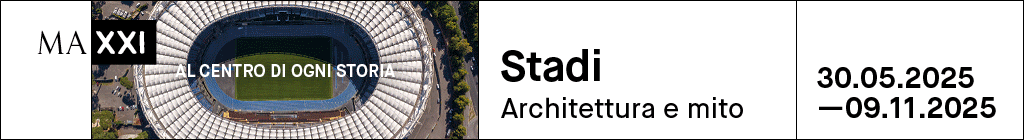Spazio pubblico e patrimonio, l’accessibilità è forma di cittadinanza
Rassegna internazionale di progetti e soluzioni: progettare per tutti aggiunge qualità allo spazio
LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DELLO SPECIALE
Published 22 luglio 2025 – © riproduzione riservata
La difficile applicazione delle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche agli immobili vincolati è stata a lungo utilizzata come alibi per evitare adeguamenti o ridurli al minimo, spesso con soluzioni tecnicamente forzate o esteticamente discutibili.
Dietro questa retorica si cela una prassi ancora diffusa, che considera l’accessibilità un’eccezione rispetto alla conservazione del bene, anziché una condizione fondativa del suo significato pubblico.
Eppure, le “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale” (DM 28 marzo 2008) invitano a una rilettura più profonda del progetto: un intervento ben risolto non crea soluzioni “speciali” per utenti “speciali”, ma genera uno spazio che, nella sua qualità, migliora la vita di tutti. In questa prospettiva, l’accessibilità diventa una prova di intelligenza progettuale e sensibilità culturale.
Gli esempi raccolti in questo articolo – diversi per scala, contesto e linguaggio – mostrano che è possibile operare nel rispetto del patrimonio, interpretando il principio dell’inclusione come parte integrante della pratica del restauro e della progettazione urbana. E, forse, come una delle sue sfide più urgenti
Siti archeologici
Affrontare il tema dell’accessibilità nei siti archeologici significa confrontarsi con stratificazioni storiche, vincoli di tutela e fragilità strutturali. In questi contesti, ogni intervento deve fondersi con la memoria dei luoghi senza forzarne la lettura, misurandosi con la materia antica, i percorsi storici e il paesaggio culturale. Negli ultimi vent’anni, Roma si è dotata di un insieme coerente di interventi che fanno della capitale un vero laboratorio di accessibilità culturale. Dal Colosseo ai Fori, dai Mercati di Traiano a Largo Argentina, la città ha sviluppato un approccio progressivo, dove l’accessibilità non è aggiunta funzionale ma parte integrante della riflessione progettuale.
Roma, Foro di Cesare, Maria Grazia Filetici, 2016
Un primo nodo del sistema accessibile dei Fori imperiali è stato il riordino del Foro di Cesare progettato da Maria Grazia Filetici e completato nel 2016. L’intervento ha reso fruibile l’area archeologica, con un percorso a livello stradale che collega via dei Fori Imperiali a via di San Pietro in Carcere, superando il dislivello tramite rampe e pavimentazioni continue. Il progetto combina la chiarezza dell’impianto moderno con il rispetto delle preesistenze, restituendo leggibilità al sito e accessibilità all’intera comunità. Nel Parco Archeologico del Colosseo, l’accessibilità ha assunto una dimensione inclusiva a 360°. Non soltanto rampe, ascensori ed elevatori per superare i dislivelli: il ParCo ha sviluppato percorsi per persone con disabilità motoria, visiva e uditiva, integrati nel contesto e promossi con strumenti di mediazione culturale. Il sistema dei percorsi accessibili è stato disegnato con materiali compatibili con le preesistenze – cocciopesto, seminati, graniglie – e rielabora il paesaggio all’ingresso del Vignola, dove una rampa a zig-zag si nasconde tra siepi formali, generando un gesto paesaggistico in continuità con il verde storico. L’intervento, guidato anch’esso da Filetici, propone un’idea di compatibilità non solo materica, ma ambientale, dove l’accessibilità genera un nuovo equilibrio percettivo. Dal 2018 al 2020 sono stati installati pannelli tattili, modelli in 3D, percorsi LIS e un ascensore panoramico che consente a tutti di accedere ai livelli superiori della cavea.
Roma, Largo Argentina, 2023
Un ulteriore tassello di questa rete è Largo Argentina, riaperto nel 2023 dopo un accurato intervento che ha consentito l’accesso al sito archeologico, per la prima volta nella storia recente. Il progetto ha introdotto nuovi percorsi perimetrali e una passerella sopraelevata che consente di camminare tra i templi dell’area sacra senza interferire con i resti antichi. I dislivelli sono superati con ascensori integrati in volumi discreti, mentre l’intervento conserva un carattere leggibile e moderno senza mimetismi forzati. Il progetto ha reso accessibile un luogo centrale della città – fino ad allora visibile solo dalla strada — offrendo nuove prospettive anche ai visitatori senza disabilità.
Pompei, Pompei per tutti, 2016
A Pompei il progetto Pompei per tutti, realizzato tra il 2015 e il 2016 da un’équipe interdisciplinare, ha costruito un lungo percorso accessibile di oltre tre chilometri, connettendo gli ingressi principali alle domus e al foro. Le soluzioni adottate – pavimentazioni in calce idraulica, passaggi metallici reversibili, reti in fibra di vetro – mostrano una sapiente attenzione alla materia e alla sua durata. Qui la tecnica si fa garanzia di leggibilità e conservazione, nel rispetto dell’identità del sito e dei suoi elementi costitutivi, come il basolato e le pietre carraie.
Atene, Acropoli, Manolis Korres, 2020
Più controverso è l’intervento sull’Acropoli di Atene progettato da Manolis Korres e approvato nel 2020. La nuova pavimentazione in conglomerato cementizio ha suscitato critiche, tra cui quelle dell’archeologo Yannis Hamilakis, per la sua presunta irreversibilità e per l’impatto visivo sul paesaggio monumentale. Il dibattito ha sollevato interrogativi sulla compatibilità materica e sull’equilibrio tra accesso e integrità del sito. I promotori del progetto hanno ribadito la temporaneità dell’intervento e la sua utilità per la sicurezza e la fruibilità, ma resta aperta la questione dell’effettiva reversibilità nel lungo periodo.
Roma, Mercati di Traiano, Nemesi, 2004
Accanto a questi progetti si colloca anche l’intervento per i Mercati di Traiano a Roma, dove la passerella di Campo Carleo (Nemesi Architects, 1999–2004) collega via dei Fori Imperiali al Rione Monti con un segno leggero in acciaio corten, distaccato dal muro romano. La struttura – autonoma, trasparente e discreta – garantisce la piena accessibilità senza occultare le preesistenze, con parapetti in cavi inox che lasciano emergere le stratificazioni. In questo caso, l’accessibilità diventa occasione per rileggere lo spazio archeologico come luogo urbano attraversabile, anche se la valenza paesaggistica resta subordinata alla logica distributiva del progetto.
Roma, Portico di Ottavia, Studio Strati, 2009
Infine, il progetto di sistemazione del Portico di Ottavia (Studio Strati, 2009) offre un esempio emblematico di come accessibilità e valorizzazione possano coesistere. L’intervento ha riorganizzato i piani di calpestio, introdotto nuove rampe e scale per superare i dislivelli e ripristinato il collegamento con l’area del Teatro di Marcello attraverso una passerella in metallo e legno. Anche in questo caso, il progetto restituisce al sito archeologico una funzione urbana, trasformandolo in spazio vissuto e accessibile.
Da questi esempi emerge un panorama articolato, in cui l’accessibilità si misura con la materia, il tempo e le forme della città storica, rivelandosi strumento critico e creativo per il progetto contemporaneo.
Spazio pubblico
Lo spazio pubblico, soprattutto nei centri storici, è spesso il luogo in cui l’inaccessibilità si manifesta con maggiore evidenza, o viene più facilmente ignorata. Rampe improvvisate, percorsi interrotti, pavimentazioni irregolari. Eppure, anche in questi contesti, l’accessibilità può diventare uno strumento progettuale, capace di rigenerare la relazione tra architettura e cittadinanza, offrendo nuovi gradi di libertà nello spazio urbano. Un caso emblematico è quello di Venezia, dove la morfologia urbana e la presenza capillare di ponti storici rendono l’accessibilità una sfida complessa e strutturale. Alla Biennale del 2012, il PEBA (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche) tracciava una prima mappatura delle aree accessibili a partire dagli imbarcaderi dei vaporetti: un’idea di città per frammenti, dove la mobilità possibile coincide con la mobilità concessa. Negli anni, piccoli ma significativi interventi hanno cercato di cucire questa trama discontinua.
Venezia, Ponte delle Guglie, 1987
Il primo fu, nel 1987, il “gradino agevolato” sul Ponte delle Guglie, una soluzione ibrida che – pur non garantendo l’autonomia – consentiva un attraversamento assistito. In seguito, rampe modulari e altri dispositivi hanno contribuito a disegnare una nuova, seppur parziale, geografia accessibile. In una città costruita sull’acqua, ogni centimetro di superamento è un atto di progettazione civile.
Bologna, Portico di San Luca, Associazione Architetti di Strada
All’opposto, a Bologna, il progetto per l’accessibilità al portico di San Luca – sviluppato in collaborazione con l’Associazione Architetti di Strada – si confronta con la monumentalità lineare di uno dei simboli cittadini. In prossimità dell’Arco Bonaccorsi, una stramp (stair-ramp), una rampa a leggera pendenza fusa nella sequenza della gradinata storica, consente il superamento del dislivello senza alterarne la percezione complessiva. Qui, come a Venezia, l’accessibilità non è solo risposta funzionale, ma un modo di restituire continuità di senso allo spazio urbano.
Architetture storiche
Non sempre l’intervento accessibile deve passare inosservato. In alcuni casi, la scelta è quella di rendere visibile e dichiarata la propria contemporaneità, stabilendo un dialogo aperto e intenzionale con il linguaggio dell’edificio storico.
Londra, Cattedrale di Saint Paul, Caroe Architecture, 2021
È quanto accade nel progetto di Caroe Architecture per la Cattedrale di Saint Paul a Londra. Completata nel 2021, la nuova rampa d’accesso si sviluppa sul lato nord del transetto come una doppia curva sinusoidale, in pietra di Portland e granito, con corrimani e balaustre in bronzo-alluminio. Non si mimetizza, non si ritrae: dichiara la propria epoca e la propria funzione, come un innesto barocco del XXI secolo. All’interno, lo spazio si apre sul memoriale “Remember Me”, realizzato a seguito della pandemia da Covid-19 per commemorare le vittime. Progettato da Connolly Wellingham Architects, il portico ovale riprende le curvature dell’esterno, trasformandosi in uno spazio di raccoglimento e di mediazione climatica. In questo caso, l’accessibilità non si limita alla funzione, ma assume un significato simbolico, ridefinendo l’ingresso monumentale come luogo della memoria collettiva.
Dispositivi meccanici
Quando i dislivelli sono significativi o le condizioni storiche non permettono l’inserimento di rampe, la tecnologia può offrire risposte eleganti. Anche in questi casi, però, la qualità del progetto si misura nella capacità di dialogare con il valore architettonico del luogo.
Firenze, Cappelle Medicee, Paolo Zermani, 2023
Alle Cappelle Medicee di Firenze, il nuovo accesso progettato da Paolo Zermani (2023) introduce un ascensore esterno, rivestito nella stessa pietra forte del campanile. La scala adiacente è contenuta in setti murari in travertino, materiali scelti con sobrietà e coerenza. L’ascensore, inizialmente previsto in corten, è stato rivestito in pietra proprio per garantirne la compatibilità mimetica. All’interno, un sistema di transloelevatori consente il superamento dei gradini obliqui, rendendo accessibile anche la Sagrestia Nuova. È un progetto che evolve nel confronto con il contesto, cercando una sintonia tra linguaggio e funzione.
Amsterdam, Borsa
Ben più discreto – ma di straordinaria ingegnosità – è il dispositivo installato alla Borsa di Amsterdam, dove una parte della scala di accesso è stata trasformata in piattaforma elevatrice a scomparsa.
Atene, Acropoli, 2020
Infine, all’Acropoli di Atene, accanto al dibattito sul conglomerato cementizio, un elemento ha raccolto un ampio consenso: l’ascensore panoramico inclinato, progettato su misura da Maspero Elevatori e consegnato nel 2020 (immagine di copertina dell’articolo). In grado di trasportare fino a 16 persone con inclinazione variabile tra 38° e 78°, collega il Peripatos all’Eretteo in meno di un minuto. Completamente trasparente, offre ai passeggeri un panorama unico sull’altopiano sacro. Un dispositivo che non solo serve, ma racconta: l’accesso diventa esperienza visiva e inclusiva, dove la tecnologia accompagna – senza prevaricare – il racconto dei luoghi.
Un progetto culturale
L’accessibilità non è una deroga, né un’aggiunta tecnica. È un progetto culturale. Gli esempi raccolti mostrano che intervenire sul patrimonio monumentale per aprirlo a tutte e tutti non implica una perdita, ma un guadagno: in senso, in significato, in qualità dello spazio.
Che si tratti di una passerella tra i templi o di una scala che si trasforma, ogni intervento accessibile è un’occasione per ripensare l’architettura come forma di cittadinanza. I criteri del restauro – reversibilità, compatibilità, distinguibilità – trovano qui un terreno di applicazione concreto e attualissimo.
Progettare per chi ha una fragilità significa, in fondo, progettare per tutti. Perché una rampa ben progettata non è una corsia per pochi, ma un’altra possibilità di attraversare il mondo. In questo attraversamento, l’architettura smette di essere barriera, e torna ad essere apertura.
Architetto e docente di Storia dell’Architettura e di Restauro presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio, Università della Svizzera Italiana. Affianca la ricerca storico-scientifica alla pratica professionale, integrando la progettazione con un aggiornamento continuo su tecnologie e materiali di ultima generazione.
Da oltre vent’anni
Studio Bettini Architetti
Associati si occupa di
restauro monumentale, riuso del costruito, allestimento degli interni.
Opera su commissioni
pubbliche e private nei contesti storici più delicati. Propone un approccio innovativo al design inclusivo
per sviluppare soluzioni progettuali che integrino accessibilità e inclusività, rispettando e valorizzando il patrimonio esistente.