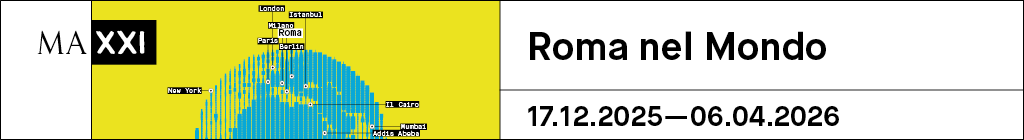Prevenire, drenare e riutilizzare è meglio che inquinare e dilavare
Ricerche e progetti per cambiare rotta in materia di tutela delle risorse idriche
LEGGI GLI ALTRI CONTRIBUTI DELLO SPECIALE «GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA»
Published 16 marzo 2022 – © riproduzione riservata
L’acqua potabile non supera l’1% del totale presente nel nostro pianeta, una percentuale molto bassa che rischia di diminuire. L’inquinamento prodotto dai pesticidi per l’agricoltura, dagli scarichi urbani senza depurazione e dalle microplastiche minaccia sempre di più il nostro pianeta, con il rischio di abbassare notevolmente la percentuale di acqua dolce. L’acqua è il “canale conduttore” in cui le molecole velenose e le nanoparticelle, composte da polimeri, trovano la via più diretta per raggiungere il nostro organismo, arrecando gravi danni alla salute.
Per i problemi legati all’inquinamento e alla mancanza di acqua, una persona su tre abbandona i propri territori, lasciando tradizioni e culture, dando incontro ad un futuro incerto (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2019). “Il solo accesso non è sufficiente. Se l’acqua non è pulita, non è sicura da bere o è troppo distante, e se l’accesso a un gabinetto non è in sicurezza o è limitato, non stiamo ottenendo risultati utili per i bambini nel mondo […]. I bambini e le famiglie delle comunità povere e rurali sono quelli maggiormente a rischio di essere lasciati indietro. I governi devono investire nelle loro comunità, se vogliamo colmare i divari economici e geografici e garantire questo fondamentale diritto umano”, afferma Kelly Ann Naylor, direttore associato dell’Unicef per i programmi di Acqua e Igiene. Affiggere cartelli e posizionare confini che riportano la frase “attenzione non inquinare le falde acquifere” è sicuramente necessario, ma non risolutivo. Bisogna avvicinare le persone con campagne educative che facciano prendere consapevolezza dei danni che si possono procurare alla fonte e alla sorgente.
Ricerca, programmi e rischi
In molti si sono occupati e si occupano della condizione della risorsa acqua nel mondo e delle strategie di miglioramento. Uno di questi è il Water Institute di Stoccolma che dal 1870 impronta la sua attività sull’approvvigionamento e la gestione dell’acqua, attualmente sotto la direzione di Aaron Salzberg. Le ricerche, i programmi e i progetti affrontati dal Water Institute toccano diversi settori disciplinari, come la blue economy, i sistemi idrici urbani e lo studio dei bacini idrografici.
L’International Water Association è un’organizzazione non governativa e no profit con sede a Londra. Associa imprese, studenti, ricercatori, docenti e progettisti per dare risposte concrete sui vari aspetti che interessano il ciclo integrato dell’acqua, approvvigionamento, inquinamento, distribuzione, gestione delle reti; essa sviluppa programmi e nuove strategie per comunicare nuove pratiche nell’uso dell’acqua e promuovere la consapevolezza e il coinvolgimento delle società per la protezione delle risorse idriche.
L’obiettivo numero 6 dell’Agenda 2030 è “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie… È anche importante per ottenere tutto ciò ripulire gli ecosistemi legati all’acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi” (Nazioni Unite, Agenda 2030). Da un’analisi sviluppata in questi ultimi anni da diversi studiosi si prevede che nel 2050 la “condizione acqua” sarà peggiorativa e che solo una persona su quattro avrà il diritto di accedere al bene più prezioso che la natura ha donato. Il 50% della popolazione mondiale sarà a rischio a causa della minaccia idrica, “la sola desertificazione minaccia i mezzi di sussistenza di quasi un miliardo di persone in 100 paesi”, spiega Munir Akram, presidente del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
Cosa si è fatto per cambiare rotta?
John Thackara, riconosciuto a livello internazionale per l’innovazione e la green economy, nel libro Progettare oggi il mondo di domani afferma che spesso ci dimentichiamo di affrontare la crisi idrica in modo sistematico: “La frattura metabolica […] ci ha fatto perdere di vista la realtà che l’acqua è un sistema vivente: anche quando ci soffermiamo a pensare all’acqua, la consideriamo un liquido che fuoriesce da un rubinetto”.
Chris Ryan è sempre più convinto che occorra un cambiamento radicale, innescando una ricerca interdisciplinare. Design e scienze sociali possono dare nuove risposte per la realizzazione di nuove tecnologie per l’approvvigionamento e la fornitura locale delle acque reflue attraverso la Water Distillation.
Progetti per assecondare l’ecologia dei luoghi
Un progetto importante è Envirosense, un sistema che controlla, attraverso sensori, i livelli d’inquinamento, rispondendo a tre interrogativi fondamentali per la ricerca dell’Unione Europea: quali sono i processi che prevengono l’infiltrazione delle sostanze inquinanti? Quali sono i cambiamenti che queste sostanze subiscono prima di raggiungere le acque sotterranee? Quali sono le conseguenze dell’attività agricola sulla qualità dell’acqua? Questo sistema ha dato la possibilità di capire quali fossero i meccanismi che portano all’inquinamento, sia alla fonte che nell’ambiente non antropizzato, e prevenire con norme che possano diminuire o abbattere completamente l’inquinamento e i nuovi metodi per il trattamento delle acque delle sostanze inquinanti.
All’inizio degli anni settanta gruppi di cittadini presero consapevolezza di quanto fosse importante il concetto di bacino idrico urbano e Richard Register, ambientalista locale, cominciò a dipingere, con lo spray, la scritta “Drains To Bay”, in prossimità delle caditoie nella città di Berkeley. Negli ultimi anni molte comunità hanno sposato l’idea di sperimentare approcci come Low Impact Development o Natural Drainage Systems, che nel Regno Unito è stato declinato come Sustainable Urban Drainage Systems (SuDS). Ricerche ambientali interdisciplinari, l’insieme di buone pratiche e di buon senso portano a comprendere l’ecologia dei luoghi.
Il geomorfologo fluviale Matt Kondolf e l’ecologo specialista di vegetazione dell’Università di Berkeley Joe McBride, docenti al corso Ecological Factors in Urban Design, sono stati i fautori della Green Street, una progettazione che prevede la raccolta e il drenaggio dell’acqua piovana, evitandone il deflusso a grande velocità, grazie a terreni permeabili e mantenendola negli invasi naturali nel luogo dove cade.
Un altro caso da menzionare è il Grey To Green della città di San Francisco, basato sulla riduzione dei picchi di flusso, sulla non contaminazione delle acque meteoriche con la rete fognante e sul ricaricare l’acquifero sotto la città per poter gestire in futuro l’irrigazione delle aree coltivate o dedicate al verde pubblico, senza l’uso dell’acqua potabile.
I progetti Run-Off Water partono da un concetto facile da applicare: una pianificazione sensibile e sostenibile che limiti al massimo le aree cementificate e renda le superfici urbane permeabili, in modo che le acque piovane possano raggiungere le falde o i corsi d’acqua. Un modo per integrare i flussi naturali a favore della salute umana e delle connessioni ecosistemiche.
Il programma europeo Prima
Un’altra nota positiva arriva dall’Unione Europea che nel 2017 ha istituito un programma congiunto promosso da 19 stati, denominato Prima (Partnerships for Research and Innovation in the Mediterranean Area) e strutturato sui seguenti tre macro-temi: gestione sostenibile dell’acqua in zone aride e semi-aride; sistemi di agricoltura sostenibile appropriati agli ecosistemi mediterranei; cibo e filiera alimentare. La sfida è quella di riutilizzare l’acqua per molteplici scopi, fornendo agli utenti finali nuovi sistemi applicativi e nuove tecnologie per il trattamento delle acque, economicamente più accessibili ed efficienti dal punto di vista energetico, senza dimenticare i principali vincoli ambientali, socioeconomici e legali che limitano l’adozione di queste tecnologie.
In Maremma, grazie al programma Prima è nata Sfera WaterFood, una serra super tecnologica che utilizza il 10% dell’acqua e del suolo con una resa 15 volte superiore rispetto alla coltivazione tradizionale di ortaggi, senza l’utilizzo dei pesticidi. Questo nuovo sistema include tecnologie per il monitoraggio dei parassiti e la micro-irrigazione, serre attive in grado di controllare in tempo reale il clima per favorire la crescita delle piante.
In Africa, imparando da animali e piante
Un altro importante progetto, seppur di natura diversa rispetto ai precedenti, è Warka Water, una struttura in materiale naturale costituita da canne di bambù, filo di ferro e tessuto in polietilene, elementi facili da assemblare con costi ridottissimi. All’apparenza un’opera scultorea, posizionata nel paesaggio etiopico e in altre aree del territorio africano, la cui funzione è quella di trasformare la rugiada e la nebbia in acqua piovana, per una raccolta giornaliera media di circa 100 litri. Il progetto è stato sviluppato da Arturo Vittori a seguito di un viaggio tra l’Eritrea e l’Etiopia dove, a fronte del grande disagio delle popolazioni nel reperire l’acqua, l’osservazione della natura mostra come molti animali e piante riescano a sopravvivere in territori ostili e in aree aride, catturando l’umidità durante la notte attraverso l’escursione termica, grazie alle loro superfici corporee.
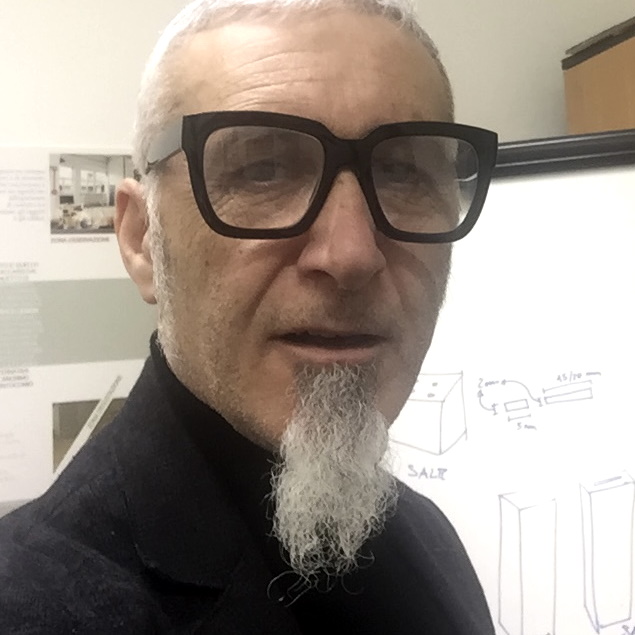
Architetto-Designer, PhD, docente al Corso di Disegno Industriale e al Master Interior Design dell’Università di Firenze e alla LABA-Libera Accademia di Belle Arti di Firenze. Visiting professor: Jiangsu College of Tecnology Enginnering, University of Nantong; Suzhou Art & Design Techology Institute; Chengdu Institute Sichuan International Studiens University (Cina). Membro del comitato scientifico Narrare i Gruppi per l’area 08/C1, Cremona; Urban Trasportation & Costruction Journal, Singapore; EnPress Publisher, USA. È direttore della collana editoriale Città e Design, Navarra Editore, Palermo. L’attività di ricerca è indirizzata allo sviluppo e alle relazioni tra Product Design e Interior Outdoor Design. Ha scritto più di 50 articoli e saggi e le monografie: “In/Out Interior Design, 2019, DidaPress, Università di Firenze;“Album disegni e progetti”, 2018, FA Editore Firenze; “Pocket Park, una stanza a cielo aperto”, 2017, Navarra Editore; “Design per la città, Il progetto degli spazi esterni”, 2016; Navarra Editore; “Ascoltare i Luoghi”, 2007, Alinea Editrice. Molti dei suoi lavori prendono parte a mostre e selezioni editoriali: Refuse Arango Design Fondation of Miami; Ri-usi Triennale di Milano; The International Design Yearbook, Londra a cura di Jean Nouvel.