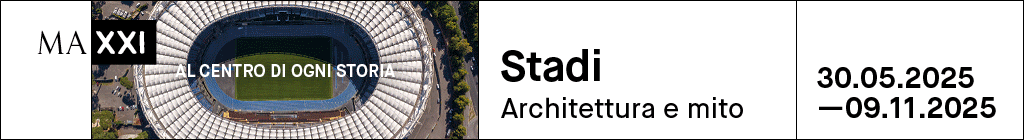La natura dell’architettura
Seconda puntata dell’approfondimento “L’autonomia del linguaggio architettonico”
LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DELLO SPECIALE
Puntata 2/4 dell’approfondimento “L’autonomia del linguaggio architettonico”
Puntata 1: Prologo: una fuga dalla realtà
Published 2 luglio 2025 – © riproduzione riservata
Per comprendere come l’architettura non possa essere un gioco solipsistico dobbiamo tornare alle origini. Anche prima della sua invenzione, infatti, i nostri antenati abitano la terra. Saranno proprio componenti spaziali del paesaggio naturale, nel corso dell’evoluzione, come vedremo, a svolgere un ruolo cruciale nel consolidare prima le emozioni e poi il pensiero concettuale.
Dall’inizio del secolo scorso, la psicologia ambientale inizia ad investigare il ruolo del contesto sul comportamento, per concentrarsi, dagli anni ’50, su ambienti costruiti e naturali. Ciò produce la crescente consapevolezza che “gli esseri umani non rispondono passivamente alle forze ambientali” (Gifford, 2011).
Nel 1976, James Gibson introduce una rivoluzione quando riconosce l’esistenza di precise relazioni tra le qualità bio-meccaniche di un organismo e gli oggetti e gli spazi con cui interagisce: le affordances. Si apre così la strada a nuovi modelli di cognizione, che la scoperta a Parma dei neuroni specchio, da parte di Giacomo Rizzolatti, Vittorio Gallese ed altri, alla fine degli anni ’80, consolida. Le scimmie, come gli umani, attivano un processo cerebrale di simulazione motoria, quando percepiscono azioni umane, anche senza esecuzione effettiva. Tutto questo avviene, però, anche quando si percepiscono configurazioni di oggetti con forme analoghe a schemi d’azione umana: è il correlato neurale delle affordances. La percezione di un oggetto attiva la simulazione cerebrale di un gesto. Emerge una nuova comprensione della cognizione umana e della sua origine sociale. Il paradigma delle 4E – embodied (incarnata), enacted (esecutiva), embedded (incorporata) ed extended (estesa) – attribuisce all’ambiente il potere di plasmare cognizione ed interazioni sociali. Il legame tra funzioni cognitive, esperienze motorie ed interazioni con lo spazio è fondamentale: le sensazioni fisiche e i movimenti modellano i nostri pensieri.
Una cognizione mentale astratta e disincarnata non esiste: il corpo è l’attore principale. Quando esploriamo i luoghi, le nostre interazioni, trasformative e dinamiche, fanno emergere l’aspetto esecutivo dall’interazione corpo-spazio. Invece, la cognizione incorporata evidenzia l’influenza dei contesti culturali su cosa sentiamo, visto che i rituali e le abitudini guidano comportamenti e pensieri. La sua dimensione estesa segnala, infine, che i processi cognitivi dipendono da risorse e strumenti esterni: l’ambiente agisce come un’estensione delle nostre capacità.
In sintesi, il paradigma delle 4E mostra che i luoghi non sono semplicemente sfondi, ovvero che le forme del nostro contesto influenzano significativamente il nostro modo di percepire. Prima della comparsa dell’architettura, l’ambiente naturale come ha influenzato lo sviluppo umano? In particolare, come le componenti dell’ambiente naturale, nelle quali gli esseri umani hanno affinato gli schemi motori d’azione, hanno prodotto la cognizione, le emozioni e lo sviluppo della coscienza?
Nella seconda metà del Novecento, lo studio della natura diviene centrale nella comprensione del disagio prodotto dagli ambienti urbani. Jay Appleton, Rachel Kaplan e Stephen Kaplan studiano l’evoluzione umana entro l’ambiente naturale.Nel mentre, alcuni esperimenti dimostrano i benefici per la salute dal rapporto con la natura. Il più noto è l’indagine di Roger Ulrich: scopre che i pazienti, in un reparto ospedaliero le cui finestre avevano la vista sul bosco, registravano una netta riduzione dei tempi di recupero post-intervento, di consumo di analgesici e chiamate notturne, rispetto a pazienti analoghi ma ospitati in camere con vista sulla facciata opposta dell’edificio.
Perché? Gordon Orians, apre una strada per rispondere a questa domanda. Il suo libro del 2014, “Snakes, Sunrises, and Shakespeare”, ricorda l’indagine da lui condotta decenni prima sulla savana africana. Con Judith Heerwagen, dimostra, in un esperimento del 1993, la persistenza di una preferenza universale innata dell’uomo per quel paesaggio ancestrale. Orians scrive: “Quando proposi l’ipotesi della savana, gli antropologi sapevano già che i nostri antenati vivevano nelle savane dell’Africa orientale durante il periodo in cui il loro cervello triplicò di grandezza. Scoprii come le forme degli alberi che dominavano le savane ricche di risorse, dove sarebbero sopravvissuti e si sarebbero riprodotti meglio, erano state particolarmente attraenti per i nostri antenati”. L’albero di acacia è un elemento chiave di quel paesaggio: non è un’immagine, infatti, ma una affordance, un meccanismo di interazione corpo-spazio. “Più vicino al suolo si trova il tronco di un albero, più facile è scalarlo”, osserva Gordon.
Aggiungiamo un tassello. Perché persiste questo ricordo così antico? Il marcatore somatico, descritto da Antonio Damasio, chiarisce il ruolo delle emozioni nel consolidare la memoria: sono le emozioni quel timbro corporeo che marca l’esperienza e la rende memorabile. Ora, quindi, possiamo comprendere come infinite interazioni cinematiche, quindi emotive con l’acacia, essenziali per la sopravvivenza, abbiano cablato la memoria del sapiens. Più tardi, nel 2010, la ripetizione dello stesso esperimento, da parte di Falk e Balling, rafforza la teoria, scoprendo come questa preferenza tenda a diminuire quando, crescendo, i paesaggi natali riscrivono le preferenze innate.
Ergo, il cervello non è una tabula rasa, ma il frutto di adattamenti sviluppati con affordances ancestrali. Nella savana africana, dove l’uomo si evolve, le pressioni della sopravvivenza determinarono risposte emotive e strutture cognitive. Le interazioni con l’acacia, con sostegni per appoggiare il corpo, superfici piane, caverne, pendii, o specchi d’acqua attivarono schemi corporei e cifre emotive interne distinte, memorizzate come componenti dei dati sensoriali motori e visivi. Si tratta della fase germinale dei modelli generativi delle interazioni corpo-spazio. Come suggerito dalla Free Energy Theory di Karl Friston, e nella cornice della Predictive Processing Theory di Andy Clark, questi modelli operano per ridurre l’entropia cerebrale, conservando l’energia metabolica per gli imprevisti, costruendo modelli per usare lo spazio in modo automatico.
Le emozioni annidate in questi modelli sensorimotori sono fondamentali per comprendere il ruolo del paesaggio naturale nell’evoluzione. L’ipotesi della affective prediction di Lisa Feldman Barrett e Moshe Bar suggerisce che il contenuto emotivo, associato ad un modello di interazione, non si manifesta dopo l’esplorazione della sezione spaziale, ma che le emozioni supportano la visione fin dall’inizio. Proprio grazie ai modelli, l’immagine attiva la corteccia orbito-frontale mediale, provocando cambiamenti muscolari e ormonali che generano emozioni corporee, dagli organi, dai muscoli e dalle articolazioni, associate a precedenti esperienze, che si integrano via via con tutte le informazioni sensoriali raccolte in progress. Gesti basilari, come salire, abbracciare, sedersi, stendersi, saltare e tuffarsi, vissuti in una dimensione corale, hanno miscelato le emozioni enterocettive con le affordances responsabili dell’innesco delle cinematiche.
I concetti, infine, emergono come oggetti non separabili dall’esperienza emotiva generata nell’interazione motoria con le affordances. Come sostengono Nicolàs Alessandroni, Lambros Malafouris e Shaun Gallagher (2024) “il pensiero concettuale è una forma specifica di coinvolgimento materiale che gli individui sono in grado di sostenere con il proprio ambiente”. Il linguaggio si è evoluto per migliorare la cooperazione e l’interazione sociale all’interno di gruppi sempre più complessi. Pertanto, la nostra architettura cognitiva e il nostro paesaggio emotivo non sono solo il prodotto della selezione genetica, ma piuttosto di un lungo e complesso processo di co-evoluzione con l’ambiente. Il risultato è la sintonia tra schemi motori e le forme spaziali in grado di innescarli: tutto ciò precede l’architettura.

Architetto, a Milano guida TA TUNING ARCH, società dedicata all’applicazione delle neuroscienze al progetto architettonico che vanta interventi nel settore dell’housing sociale, delle residenze per anziani, ospedali, aeroporti, logistica, scuole, uffici. Ha fondato e dirige NAAD Neuroscience Applied to Architectural Design, ad oggi nel mondo il primo Master internazionale nato sullo stesso tema, all’Università Iuav di Venezia. Ha co-fondato la nuova rivista «Intertwining», sul rapporto tra scienza, cultura umanistica e architettura, edita da Mimesis International. Ha pubblicato “L’architettura delle differenze” (2013) e “Tuned Architecture” (con Vittorio Gallese, 2016), oltre a saggi e articoli in varie riviste d’architettura. Sempre presso Mimesis è stato pubblicato “Tuning Architecture with Humans” (2023)