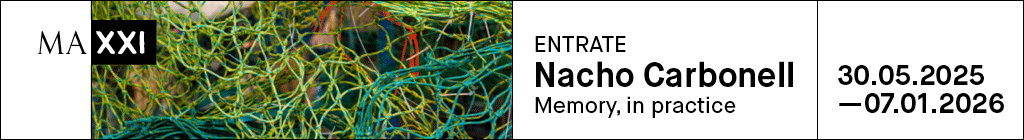La città che abbiamo in testa
Puntata finale dell’approfondimento “L’autonomia del linguaggio architettonico”
LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DELLO SPECIALE
Puntata 4/4 dell’approfondimento “L’autonomia del linguaggio architettonico”
Puntata 1: Prologo: una fuga dalla realtà
Puntata 2: La natura dell’architettura
Puntata 3: L’invenzione dell’architettura: un motore sociale
Published 27 agosto 2025 – © riproduzione riservata
Nel corso della storia, le città e l’architettura trasformano senza sosta i modelli di interazione corpo-spazio sviluppati sin dalle prime fasi dell’evoluzione. Tuttavia, in Occidente, dai villaggi del Neolitico alle antiche città greche e romane, attraverso il Medioevo, il periodo gotico, il Rinascimento sino all’epoca neoclassica, l’organizzazione dello spazio rimane centrata sul corpo, anche quando le forme sono progettate per manipolare le sensazioni, come diventa usuale a partire dalle prime città-stato.
Nuove tecnologie e un massiccio afflusso di persone provenienti dalle aree rurali, avviano la Rivoluzione Industriale, portando un cambiamento improvviso nel modo di fare le città. Oggi, al netto dei quartieri storici e di rare isole otto-novecentesche, le nostre città si stanno sempre più trasformando in ambienti che mettono a rischio la salute mentale.
Non consideriamo, in questo quadro, la crisi climatica e l’inquinamento, che pur rivestono un ruolo pesante. Concentriamoci su tre condizioni delle quali non abbiamo coscienza, ma che giocano un ruolo chiave: la sempre più debole produzione di mappe mentali dell’ambiente urbano, la sottile sensazione di frustrazione nella navigazione degli spazi costruiti, e l’incapacità di troppi ambienti di attivare l’immaginazione.
Quando queste tre condizioni si sommano, determinano uno stress cronico che influenza negativamente la salute psicologica, fisica, e neurobiologica. Incertezza, distacco e deprivazione sono le tre parole chiave che sintetizzano un progetto che incorpora questi fattori. Dopo 14 millenni d’architettura disegnata sugli schemi di interazione corpo-spazio derivati dall’evoluzione nella natura, negli ultimi due secoli abbiamo dilapidato questa eredità.
Le mappe mentali e la salute dell’ippocampo
La mappa mentale di un luogo è una rappresentazione cognitiva che permette di comprendere, orientarsi e ricordare le relazioni spaziali tra oggetti e edifici, organizzando e codificando informazioni su distanze, direzioni e caratteristiche dello spazio. Le mappe mentali sono essenziali per la vita quotidiana e la comprensione di ambienti complessi.
I punti di riferimento facilitano la formazione e il richiamo delle mappe, permettendo di pianificare le rotte. Le emozioni, combinazioni di modifiche fisiologiche, giocano un ruolo fondamentale nella costruzione della memoria, migliorando codifica e conservazione delle esperienze dello spazio.
Proprio i landmarks, evocando emozioni, creano indizi riconoscibili e aiutano la costruzione di mappe zenitali. Quando le emozioni sono intense l’amigdala interagisce con l’ippocampo creando ricordi vividi: questa co-attivazione rende più accessibili i ricordi marcati rispetto a quelli neutrali, modellando richiamo e apprendimento.
L’esplorazione egocentrica dello spazio si basa su una personale prospettiva e sui dati raccolti sulla retina. Al contrario, la navigazione allocentrica implica la memorizzazione delle relazioni spaziali tra edifici in modo indipendente dalla memoria delle sequenze, affidandosi a segnali esterni e a punti di riferimento per costruire una mappa mentale più estesa.
Facciate porose, che dall’esterno favoriscono la percezione d’azioni interne, o l’uso di dettagli significativi, creano landmarks in grado di evocare risposte somatiche, ovvero emozioni. Le azioni umane, infatti, percepite da osservatori esterni inducono simulazioni implicite, non consapevoli, cariche di valenze emozionali. Al contrario, facciate prive di aperture inibiscono ogni tipo di simulazione mentale e cancellano punti di riferimento, rendendo difficile la memorizzazione. Le mappe, così, faticano a trovare i ganci dai quali partire per realizzarsi.
Distacco emotivo e stress cronico
Bessel van der Kolk definisce il trauma come un’esperienza che travolge una persona, compromettendo il senso di sicurezza e l’identità. Il trauma influisce sulla regolazione emotiva, sulle relazioni e può manifestarsi anche a livello fisico. Aldilà dei traumi drammatici, vediamo come microtraumi più leggeri, ma ripetuti, influenzino il nostro quadro mentale.
Le esperienze del quotidiano (imparare, lavorare o condividere il cibo, ad esempio) hanno ognuna qualità fenomeniche uniche che influenzano il comportamento ed attivano attese sensoriali distinte: imparare evoca leggerezza, lavorare il senso di attivazione, mentre la condivisione del cibo il calore. Attese emotive che rendono palpabile la relazione tra azioni, significato ed emozioni. Nel corso del giorno, le nostre esperienze si confrontano sempre con eventi passati analoghi. Questo ci porta a fare leva sulla memoria, per adattare comportamenti, costruire resilienza, favorire la crescita emotiva, attraverso meccanismi di coping.
Nei modelli di Predictive Processing dell’interazione corpo-spazio, le sensazioni sono fondamentali per anticipare le risposte al contesto ambientale. Le aspettative guidano il comportamento, migliorano la consapevolezza spaziale e informano le decisioni. La Generalized Unsafety Theory of Stress fornisce un’ulteriore prospettiva: i ricercatori suggeriscono che anche un senso di insicurezza costante, percepito inconsciamente, produce stress.
Mantenendo uno stato di allerta ed ansia elevato, questo prolungarsi della sensazione può portare a uno stress cronico, influendo su salute e benessere. Le emozioni corporee (calore, leggerezza, equilibrio) sono i nuclei enterocettivi di schemi primordiali d’azione corpo-spazio evoluti nel corso della storia umana. Questi schemi, di natura spaziale, costituiscono quella che potremmo chiamare la dimensione architettonica dell’affettività.
La simulazione motoria e il cervello
Vittorio Gallese definisce la simulazione incarnata come il meccanismo neurale che permette di comprendere e replicare le azioni, le emozioni e le esperienze degli altri attraverso un processo cerebrale involontario di rispecchiamento. Questo favorisce la comprensione empatica e la cognizione sociale attivando risposte neurali simili a quelle utilizzate per le proprie azioni. Anche quando percepiamo l’architettura, l’interazione dinamica integra tutti i dati sensoriali raccolti durante la navigazione, e plasma le risposte alle forme spaziali. Attraversando i luoghi, le percezioni cambiano lungo una linea temporale, e l’interazione multisensoriale favorisce risposte emotive più ricche e una comprensione più profonda dell’architettura.
Le emozioni corporee emergono dall’integrazione di dati sensoriali, come ritmi cardiaci e respiratori, tensioni delle fibre lisce dell’intestino, il milieu chimico, la pressione sanguigna e la temperatura. Se questi forniscono al cervello i segnali interni del corpo, il sistema muscolo-scheletrico offre, invece, insieme all’orecchio interno, le informazioni sulla posizione e i movimenti esterni del corpo.
In azione, il tronco può aprire o chiudere la sua forma, gli arti estendersi o portarsi vicino al suo centro, mentre la testa può oscillare in su o in giù. Questi sono movimenti corporei reali che eseguiamo realmente o, secondo la teoria dei neuroni specchio, che simuliamo mentalmente.
Durante l’esplorazione di una stanza e dei suoi confini materiali, la sfera definita dalla potenziale estensione degli arti (lo spazio peripersonale) viene compressa e decompressa. Questa fluttuazione dinamica modifica la distanza percepita tra corpo e limiti, provocando sottili variazioni nel bilanciamento del corpo. Queste configurazioni di testa, tronco, arti e torace, continuamente riassemblate seguendo l’interazione con i confini, innescano simulazioni di cinematismi motori memorizzati nel corso dell’evoluzione: appoggiarsi, sdraiarsi, salire, saltare, abbracciarsi, ed altri ancora.
Il nostro cervello simula uno schema motorio completo anche a partire dalla percezione coerente di pochi dei suoi dettagli, allo stesso modo di come un sorriso particolare può attivare la simulazione di un abbraccio, o il suono dell’acqua che scorre il riaffiorare del senso di freschezza legato al tuffo.
Fino all’avvento delle città moderne, l’architettura è stata un fattore protettivo poiché, nel corso della sua storia, ha evoluto e arricchito i modelli primordiali continuamente perfezionati dall’ambiente naturale. Negli ultimi due secoli, la diffusione di architetture deprivate di quelle interazioni dinamiche tra i confini interni, perfezionate dall’evoluzione, ha causato un effetto deleterio sulla salute cerebrale: l’indebolimento della simulazione incarnata. Questo passaggio merita attenzione particolare. I movimenti reali stimolano il rilascio del Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF), una proteina essenziale per proteggere e supportare la regione ippocampale, favorendo la neurogenesi, la plasticità sinaptica e il funzionamento cognitivo complessivo.
Questo processo aiuta a mantenere in buona salute l’ippocampo, migliorando memoria e capacità di apprendimento e contribuendo alla resilienza contro le malattie neurodegenerative. Tuttavia, anche l’immaginazione motoria prodotta dalla simulazione incarnata, che è correlata con il sistema dei neuroni specchio, può ottenere risultati positivi analoghi.
Questa può innescare una risposta fisiologica simile a quella dell’azione reale, sebbene d’intensità ridotta. “Questi risultati dimostrano che la simulazione mentale dell’azione può attivare variazioni del battito e della respirazione. Suggeriscono che l’attivazione autonomica durante l’immaginazione di un’azione è legata al fenomeno più generale della preparazione all’azione”, ricorda Marc Jeannerod.
Accanto alle simulazioni mentali di un’azione, si attiva la risposta autonomica e la sua dimensione affettiva, enterocettiva. Non ultimo, anche le caratteristiche strutturali del cervello cambiano. Il cervelletto, l’ippocampo e il sistema dei neuroni specchio sono coattivati dalla simulazione delle azioni motorie, nel tempo e nello spazio. Diversi studi collegano il BDNF con i volumi di materia bianca e grigia nelle regioni ippocampale e cerebellare. Dopo un ictus, infatti, vengono utilizzate terapie di recupero basate proprio sull’immaginazione motoria. Altri studi in VR (realtà virtuale), inoltre, evidenziano come l’immaginazione motoria, senza esecuzione motoria reale, possa aumentare la materia bianca e grigia se l’ambiente virtuale è progettato con un approccio che spinge ad una navigazione allocentrica.
In conclusione, architetture neutre prive di narrative interne, spoglie di dinamismo ancestrale tra i confini percepiti nel corso della navigazione non innescano micro-variazioni posturali, indebolendo così la simulazione incarnata e l’immaginazione motoria. Tutto ciò influenza negativamente la salute cerebrale e indebolisce le aree dell’ippocampo e del cervelletto.
Immagine di copertina: © Ritesh Singh (pexels.com)
![]()
Paragrafo 1: lo sviluppo dell’Alzheimer e alcune forme di demenza sono correlate all’atrofia dell’ippocampo. In un esperimento condotto presso la McGill University a Montreal, i ricercatori hanno dimostrato che soggetti sani portatori del gene APOE4 (indicatore del potenziale sviluppo della malattia) possono essere divisi in due sottogruppi: uno incline ad esplorare lo spazio in modo egocentrico e un altro che utilizza una strategia allocentrica. Se l’efficacia della navigazione è uguale, la scansione magnetica del cervello ha rivelato che coloro che usavano un approccio basato sulle mappe mentali avevano più materia grigia nella regione ippocampale e un rischio minore di sviluppo dell’Alzheimer. Favorire la percezione di scene di vita in atto nelle facciate degli edifici produce landmarks, i quali facilitano la creazione di mappe mentali dello spazio urbano, riducendo il ricorso alla memorizzazione dello spazio come il GPS delle auto.
Paragrafo 2: la sensazione di leggerezza è intrinsecamente legata al salto, così come il calore all’abbraccio. Ne consegue che, l’incoerenza tra le emozioni corporee attese, proiettate come esito di una esperienza in corso, e le forme spaziali disegnate per ospitarla, costringendo il cervello a costosi adattamenti, produce microtraumi. Le stanze che accolgono le nostre esperienze sono troppo spesso disegnate senza la benché minima consapevolezza della sintonia attesa tra le nostre proiezioni (sensazioni corporee) e ciò che percepiamo nell’uso dello spazio. Il distacco emotivo prodotto dal ripetersi di questi scollamenti genera una costante insicurezza e stress cronico.
Paragrafo 3: in un esperimento in realtà virtuale, condotto a Parma, abbiamo registrato serie di attivazioni della corteccia cerebrale in risposta ad ambienti interni: è emerso che la forma architettonica influenza il giudizio sulle sensazioni espresse dai corpi di avatar presentati, dopo una prima navigazione, con posture corporee fisse. I gesti degli avatar, già testati in esperimenti paralleli, vengono percepiti in modo diverso in ragione della forma della stanza che i partecipanti esplorano. Ciò è dovuto ad un effetto di abituazione: se una stanza elicita attivazione, il gesto di un avatar, precedentemente considerato attivante, in quel contesto viene percepito come meno attivante. Il tracciato EEG ha rilevato, inoltre, attivazioni nelle aree cerebrali premotorie circa duecento millisecondi prima della comparsa degli avatar in VR, dimostrando come sia proprio la forma della stanza ad innescare nel cervello la simulazione di movimenti. In modo ancor più familiare, quando attraversiamo una soglia profonda e bassa, il nostro torace e gli arti si avvicinano leggermente. Entrando, poi, in un volume molto più alto, alziamo il mento e il tronco si apre. Questa sequenza posturale è l’accenno di un più ampio schema di interazione corpo-spazio: il salto. Prima la compressione per caricare l’energia e poi l’estensione verso l’alto. In sintesi, anche parziali modificazioni, eseguite o percepite, possono attivare la simulazione implicita di un esteso cinematismo corporeo, insieme al suo marker affettivo. Le metafore sensomotorie affondano le radici in questo intreccio, come ci suggerisce il linguaggio. “Fare un salto di qualità” è una metafora universale che racchiude l’essenza fenomenologica della crescita: la leggerezza. Durante la navigazione, i confini spaziali possono riattivare la simulazione di cinematiche primordiali, ovvero di schemi motori innati che, come abbiamo visto, sono stati consolidati nel corso dell’evoluzione umana.

Architetto, a Milano guida TA TUNING ARCH, società dedicata all’applicazione delle neuroscienze al progetto architettonico che vanta interventi nel settore dell’housing sociale, delle residenze per anziani, ospedali, aeroporti, logistica, scuole, uffici. Ha fondato e dirige NAAD Neuroscience Applied to Architectural Design, ad oggi nel mondo il primo Master internazionale nato sullo stesso tema, all’Università Iuav di Venezia. Ha co-fondato la nuova rivista «Intertwining», sul rapporto tra scienza, cultura umanistica e architettura, edita da Mimesis International. Ha pubblicato “L’architettura delle differenze” (2013) e “Tuned Architecture” (con Vittorio Gallese, 2016), oltre a saggi e articoli in varie riviste d’architettura. Sempre presso Mimesis è stato pubblicato “Tuning Architecture with Humans” (2023)