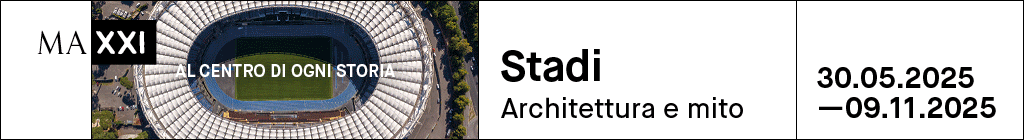La casa intorno al letto
Dal cubiculum romano all’abitacolo di Bruno Munari
Published 19 ottobre 2022 – © riproduzione riservata
La camera (dal latino camĕra, dal greco kamár, “soffitto a volta di una stanza”) già in epoca romana aveva assunto il significato generico di locale di un edificio. Oggi, con questo termine definiamo spesso la sola camera da letto che per i romani era il cubicolo (dal latino cubiculum, “stanza da letto”): un piccolo ambiente, generalmente affiancato ad altri simili, intorno all’atrio. Gli antichi romani però, avevano abitudini diverse dalle nostre, le loro camere erano celle buie con pochi arredi, destinate solo al riposo.
Il luogo deputato al sonno è cambiato molto nel corso dei secoli: le camere sono diventate un luogo di socializzazione (i “social” ci accompagnano anche a letto), un luogo tranquillo per portare a termine un lavoro od operare in smart working (da qui la proliferazione di scrivanie), o un santuario in cui fuggire dal trambusto del mondo esterno (ed ecco l’immancabile comoda poltrona).
Quando si parla di zona notte in genere s’intende quella parte della casa destinata alla camera da letto, e quindi al risposo e al relax, dove si legge un libro o si guarda un film. Anche negli appartenenti più piccoli questa stanza tende ad essere separata dal resto degli ambienti della casa, ma capita sempre più frequentemente che la zona notte coincida con il soggiorno e la cucina. In ogni caso rimane un ambiente o una parte della casa molto personale dove compiamo “riti quotidiani”: proprio come il design, anche il sonno è un’esperienza da non dare per scontata e da progettare.
Da fine Ottocento al Movimento moderno
Le camere da letto hanno visto molti cambiamenti legati al diverso utilizzo ed esigenze. Dalla metà del XIX secolo, ad esempio, accanto alla camera troviamo ambienti dedicati a ospitare le funzioni di servizio quali il guardaroba, lo spogliatoio e un salottino a uso privato. Nei primi anni del Novecento si assiste a una tendenza opposta che vede la camera da letto come mondo privato attrezzato a svolgere la funzione di piccolo soggiorno con uno scrittoio, un tavolino con sedie per il tè e, a volte, un divano letto per il riposo diurno. Un esempio è la camera da letto padronale della Hill House in Scozia progettata da Charles Rennie Mackintosh (1902).
In seguito il Movimento moderno tenderà a ridurre all’essenziale: funzionalità, praticità e trasformabilità le parole chiave di questo periodo. Le Corbusier è indiscutibilmente uno dei riferimenti: basti pensare alla zona notte di villa Savoye a Poissy (1928), dove questa funzione è riletta in “momenti” caratterizzati da diversi livelli d’intimità. Non sono più ambienti delimitati: il bagno padronale relega in un ambito chiuso solo la parte funzionale più intima, mentre posiziona in corrispondenza dell’accesso della camera da letto il lavandino, la vasca e la celebre chaise longue in piastrelle a ridosso del letto. L’architetto di origine svizzera propone oggetti quasi privi di consistenza fisica, come si può notare in particolare nel progetto della camera da letto per la Maison du Brésil, presso la città universitaria internazionale di Parigi (in collaborazione con Charlotte Perriand): rappresenta la definizione di essenzialità e funzionalità attraverso complimenti d’arredo che sembrano senza tempo.
Nella Harrenstein’s family bedroom ad Amsterdam di Gerrit Rietveld (1926), la camera da letto diventa una composizione equilibrata che segue i dettami De Stijl. È composta da mobili e piani che dividono lo spazio come in un quadro di Piet Mondrian. La tavolozza dei colori, in particolare nero, bianco, grigio, rosso, giallo e blu, ricorda inoltre la casa Rietveld Schröder a Utrecht (1924).
Dopo la guerra, Mollino e Johnson
In Italia negli anni quaranta Carlo Mollino stravolgerà il consolidato ambiente della camera. In una delle case progettate per Giorgio Devalle a Torino (1940), egli s’ispira al mondo dei sogni e del surrealismo, alle opere e ai dipinti di Hans Arp, Salvador Dalí, Man Ray, Giorgio de Chirico. Mollino allestisce interni opulenti che infrangono le regole, giustapponendo oggetti d’antiquariato con i suoi arredi ipermoderni. La camera da letto, interamente rivestita in tessuto con lavorazione capitonné, trasforma lo spazio in un’alcova accogliente e piacevole al tatto. Si accede attraverso una porta a specchio, inserita in un’ampia parete vetrata, che rappresenta un interno nell’interno: le pareti del bagno, il soffitto in tessuto lilla e il divano verde oliva ai piedi del letto a baldacchino si contrappongono al tendaggio rosso su cui, omaggio al surrealismo, è adagiata una mensola e uno specchio con cornice. Le porte, sempre in specchio, celano le connessioni tra gli ambienti.
Atmosfera completamente opposta nella Brick House a New Canaan (Connecticut, 1950), esternamente simile a un bunker, dove Philip Johnson progetta una camera da letto minimalista ma estremamente calda e avvolgente simile a un bozzolo, con soffitti a volta e pareti ricoperte da tessuti e morbida moquette.
Anni sessanta e settanta, Joe Colombo, Bruno Munari e Carlo Scarpa
Nel periodo, le camere da letto spesso vengono rilette come “microarchitetture”. Tra i progetti più noti, le “macchine per abitare” frutto della ricerca di Joe Colombo e del suo interesse per il concetto di “non arredo”. Tale idea dello spazio convertibile la troviamo nel letto Cabriolet (1969), con baldacchino retrattile e un sistema d’illuminazione in grado di simulare le condizioni diurne o notturne che consentiva di godere di un inedito livello di privacy e comodità, comprendendo un accendisigari integrato, una radio, un telefono e un ventilatore elettrico. Massima espressione di queste idee si trova nella Total Furnishing Unit (1972), un grande blocco, teoricamente portatile, che comprendeva elettrodomestici da cucina e contenitori, librerie e televisione, bagno, armadio e un letto trasformabile.
Nel 1971 Bruno Munari progetta “Abitacolo”, all’apparenza un semplice telaio in acciaio che definisce una struttura abitabile con un supporto quasi invisibile: un letto multifunzionale, una composizione che può originare svariate combinazioni, per altrettanti utilizzi. Si tratta di un’architettura essenziale dove la presenza di ogni componente è motivata, la quale che sfrutta al massimo lo spazio, quasi “ampliandolo”. Non a caso, nel 1979 “Abitacolo” fu insignito dell’XI Compasso d’Oro e successivamente inserito nella collezione permanente del MoMA di New York.
Nella Casa Ottolenghi a Bardolino (Verona, (1974-79), Carlo Scarpa elabora invece un inconsueto schema planimetrico senza limiti ben definiti negli interni. La camera da letto, quindi, non segue uno schema planimetrico tradizionale, ponendosi quasi in continuità con la zona giorno. A fare da filtro, il bagno dalla forma circolare, che si pone come diaframma tra il salone e la camera da letto. Il vetro riflettente, collocato sull’unica parete piana del volume, permette di osservare senza essere osservati: chi utilizza il bagno è in contatto visivo con l’intera camera, ma è invisibile a chi la fruisce; il letto, in primo piano, è affiancato a un camino.
L’oggi
Le tendenze contemporanee vedono attorno al letto, l’elemento che non varia nell’arredo, un variegato mondo di contenitori, oggetti, apparati e impianti per la cura del corpo, lo svago e il lavoro che rendono la stanza, un tempo deputata al riposo, luogo dalle diverse personalità. Se è vero che essa è sempre più simile a un salotto dove si svolgono molteplici attività, va tuttavia osservato che, quando i metri quadrati scarseggiano, spesso è proprio l’area notte a sacrificarsi.
I progetti dei grandi maestri c’insegnano, al di là delle riproducibili atmosfere, che una buona progettazione è importante per migliorare la qualità del sonno; soprattutto perché la camera da letto è un luogo speciale, non solo una parte della casa. È un rifugio dove accadono molte cose: l’amore, la morte, la nascita, gli incontri e le separazioni, sentimenti che rimangono racchiusi in questa stanza, e che hanno quindi bisogno di essere avvolti in un “involucro” speciale.
Nata a Garbagnate Milanese (1980), presso il Politecnico di Milano si laurea in Architettura nel 2005 e nel 2012 consegue un master. Dal 2006 collabora alla didattica presso il Politecnico di Milano (Facoltà di Architettura) e presso la Facoltà di Ingegneria di Trento (Dipartimento di Edile e Architettura). Dal 2005 al 2012 svolge attività professionale presso alcuni studi di architettura di Milano. Dal 2013 lavora come libero professionista (aap+studio) e si occupa di progettazione di interni, allestimenti di mostre e grafica. Dal 2005 collabora con la Fondazione Pistoletto e dal 2013 con il direttivo di In/Arch Lombardia. Ha partecipato a convegni, concorsi, mostre e scrive articoli per riviste e testi