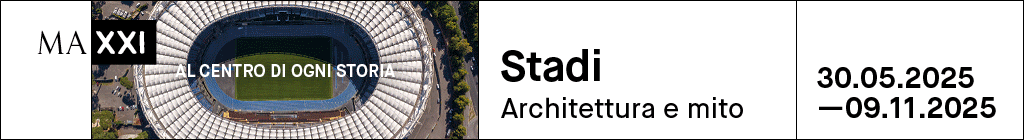Argentina
La Vértigo Horizontal del paesaggio, quello delle sterminate pampas e quello realizzato dall’uomo dopo il 1983, sono al centro di un padiglione suggestivo che si espande ben oltre i suoi confini fisici
“… la più frequente tra tutte quelle espressioni, che troviamo succeda quel che succeda e costi quel che costi, è la famosa definizione di La Rochelle: la pampa: vertigine orizzontale” (El río sin orillas, Juan José Saer).
Curata da Javier Mendiondo, Pablo Anzilutti, Francisco Garrido e Federico Cairoli, la partecipazione dell’Argentina alla 16. Biennale parte da qui per addentrarsi in un freespace fisico, metaforico e politco che restituisce un territorio come costruzione collettiva in cui dialogano il paesaggio e l’ambiente costruito.
In un allestimento minimale e d’effetto, assoluta protagonista è una grande teca di vetro che, circondata da un buio quasi totale, riesce a immergere il visitatore nella “Vértigo Horizontal” di un tipico paesaggio rurale argentino. Proiezioni, luci, ripetizioni e le riflessioni di un suggestivo gioco di specchi attivano i sensi dello spettatore: con l’accompagnamento del rumore di una pioggia temporalesca (che riesce anche a rinfrancare il visitatore spossato dal caldo umido veneziano), lo spazio è amplificato e la dritta linea dell’orizzonte si estende al di là dei confini fisici della teca e diventa infinita. Ai lati, il susseguirsi dei progetti è presentato dentro due strisce continue retroilluminate che, perfettamente allineate alla linea d’orizzonte, diventano vere e proprie fughe di una prospettiva centrale che convergono all’infinito.
I progetti, illustrati da schizzi commentati da didascalie essenziali, sono legati da un fil rouge che rende il freespace reale e metaforico al tempo stesso. Espongono un catalogo ragionato di 46 esempi realizzati di rinnovamento che a partire dal 1983, anno di ripristino della democrazia nel paese, hanno cercato d’infondere spirito democratico e principi di uguaglianza attraverso l’architettura e l’urbanistica, ridisegnando spazi pubblici e collettivi e realizzando musei, centri culturali e sociali e università. Troviamo così progetti di Clorindo Testa e Rafael Iglesia ma anche di molti altri progettisti meno noti alle nostre latitudini.
Nonostante l’impostazione del progetto e i suoi contenuti approccino il tema suggerito da Yvonne Farrell e Shelley McNamara in modo non particolarmente originale, è un padiglione che merita di essere visto (anche solo per sfuggire alla calura).
Architetto e dottore di ricerca in Storia dell’architettura e dell’urbanistica, si laurea e si abilita all’esercizio della professione a Torino. Iscritta all’Ordine degli architetti di Torino, lavora per diversi studi professionali e per il Politecnico di Torino, come borsista e assegnista di ricerca. Ha seguito mostre internazionali, progetti e pubblicazioni su Carlo Mollino e dal 2002 collabora con “Il Giornale dell’Architettura”, dove segue il settore dedicato alla formazione e all’esercizio della professione. Dal 2010 partecipa attivamente alle iniziative dell’Ordine degli architetti di Torino, come membro di due focus group (Professione creativa e qualità e promozione del progetto) e giurata nella 9° e 10° edizione del Premio Architetture rivelate. Nel 2014 fonda lo studio Comunicarch con Cristiana Chiorino, che, focalizzato sulla comunicazione dell’architettura, fa anche parte del network internazionale Guiding Architects. Co-fondatrice nel 2017 dell’associazione Open House Torino, è attualmente caporedattrice de “Il Giornale dell’Architettura” e curatrice de “Il Giornale dell’architettura, il nostro primo podcast”.