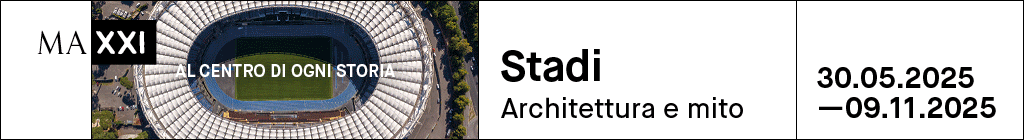Verso una critica dell’inclusività in architettura
Riflessioni del curatore a margine dello Speciale: una rilettura dei contributi con i temi emergenti
LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DELLO SPECIALE
Published 19 agosto 2025 – © riproduzione riservata
Un filo rosso attraversa tutti i contributi dello Speciale dedicato ai temi dell’inclusività: il progressivo ribaltamento del concetto di disabilità, che da “caratteristica intrinseca della persona” diventa “prodotto dell’interazione tra condizioni di salute e ambiente costruito”.
Dallo spazio che esclude al progetto che abilita
Come sottolinea Lucia Ferretti, “la disabilità non risiede nella persona, ma è la società normocentrica che disabilita l’individuo”, mentre Aimi Hamraie, nell’intervista curata da Chiara Alessi, evidenzia come “gli standard – l’utente bianco, maschio, abile e di classe media – siano nati attraverso determinati modi di conoscere e misurare i corpi”. Questo ribaltamento investe la responsabilità stessa dell’architetto, chiamato a progettare non per un utente teorico e normalizzato, ma per corpi reali nella loro irriducibile diversità.
Una possibile risposta progettuale è quella che nel nostro studio abbiamo tentato di definire “Design Ability”: non più il corpo che si adatta allo spazio, ma il progetto che si dimostra abile e capace di rispondere a esigenze diverse, pur nella consapevolezza che non esiste ancora un protocollo consolidato per questa pratica.
Come ho mostrato alcune architetture museali contemporanee, dal Guggenheim di Frank Lloyd Wright al MAXXI di Zaha Hadid, pur conferendo “qualità espressiva agli spazi che racchiudono non sono accessibili e divengono discriminatorie escludendo alcuni dalla completa esperienza architettonica”. Qui si misura il fallimento di un’architettura-spettacolo che, nascondendo dietro la pretesa di universalità della forma la propria incapacità di includere, perpetua meccanismi di esclusione.
L’impossibile universalità
La critica al mito dell’universalismo progettuale emerge con forza dai diversi contributi. Elena Granata denuncia come “siamo talmente assuefatti al paesaggio urbano che ci circonda da non renderci più conto di quanti divieti, ostacoli e dissuasori delimitino il nostro movimento”, mentre Federico De Rosa immagina provocatoriamente un’isola dove gli edifici sono pensati per i neurodivergenti: ambienti magari compressi, chiusi, dove non si sentono rumori nei quali i normodotati si sentirebbe a disagio.
Questo paradosso – l’impossibilità di soddisfare contemporaneamente esigenze contraddittorie – emerge drammaticamente anche nei memoriali più sensibili. L’installazione di Christian Boltanski al Museo della Memoria di Ustica, con le 81 vittime ricordate attraverso altrettante luci che si accendono e si spengono al ritmo di un respiro mentre 81 altoparlanti emettono frasi sussurrate dietro specchi neri, crea un’esperienza di straordinaria intensità emotiva.
Eppure, come è emerso in una conversazione con Anna Bernardi, per chi non sente l’intervento risulta mutilo di una componente essenziale, rendendo necessari supporti visivi che tuttavia rischiano di alterare l’impatto dell’opera. Anche l’empatia più profonda può generare involontariamente esclusione. Questo paradosso ci obbliga a riconoscere l’onestà intellettuale come valore progettuale. Non esistendo l’utente tipo inclusivo, ogni progetto diventa un atto di mediazione specifica tra esigenze reali in contesti reali, con risorse finite e vincoli concreti. Come emerge dal lavoro sui PEBA (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) e sui PAU (Piano Accessibilità Urbana) che Valeria Tatano segnala in crescita, la sfida non è trovare la soluzione universale, ma sviluppare metodologie di progettazione situata.
Il progetto come esperienza incarnata
L’esperienza di architetti che hanno vissuto in prima persona la disabilità rivela dimensioni del progetto spesso inaspettate. Chris Downey, nell’intervista di Jacopo Gresleri, dimostra come “il progetto architettonico non è funzione di ciò che vedono gli occhi, ma piuttosto di ciò che vede l’occhio della mente”. Ma è forse Michael Graves a offrire la testimonianza più radicale di questa trasformazione: dopo una grave infezione che nel 2003 causò una lesione spinale, rivendicò apertamente come la propria condizione avesse affinato una nuova sensibilità progettuale. “Poiché la paralisi non mi ha tolto la capacità di progettare e anzi mi ha reso un progettista migliore, sono rimasto integro – affermava – Da allora ho chiesto al mio team di progettazione di trascorrere una settimana su una sedia a rotelle”.
Questa pratica dovrebbe essere estesa: gli architetti, una volta terminate le loro opere, dovrebbero farne esperienza diretta con diverse limitazioni fisiche – in sedia a rotelle, con bende agli occhi, con cuffie che eliminano i suoni esterni, con dispositivi che limitano la mobilità degli arti – vivendo loro stessi in quelle condizioni gli spazi che hanno progettato. Si renderebbero conto che per renderli accessibili servono soluzioni articolate, non solo un ascensore o lunghe e faticosissime rampe.
L’esperienza del Guggenheim o del MAXXI dimostra come anche architetture iconiche possano escludere proprio nella loro qualità espressiva più celebrata. Non basta allora che le architetture siano rispondenti alle norme di accessibilità: la cifra della loro inclusività si misura nella possibilità che tutti possano farne autentica esperienza. Questa dovrebbe essere una qualità fondativa dell’architettura, non un’aggiunta.
La stessa drammatica consapevolezza emerge dalla testimonianza del fisico Marcello Ceccarelli che nei primi anni Sessanta commissionò a Giancarlo De Carlo sulle colline di Bologna una casa privata realizzata interamente sul sistema a raumplan loosiano, con spazi articolati su un’infinità di piccoli dislivelli. Quando Ceccarelli contrasse la sclerosi multipla, la sua condizione di progressiva paralisi venne amplificata dalla concezione stessa della casa. Come scrive nel breve racconto autobiografico “Viaggio provvisorio. Breve storia di un uomo, della sua sclerosi a placche e di un esperimento finora mal riuscito” (1976): “una bella nuova casa (piena di gradini: 46 su otto piani diversi. Più altri venti per arrivare al garage)”.
Il corpo vulnerabile diventa così misura e generatore dello spazio. Come scriveva Graves: “Non potevo più ignorare le cose che prima non vedevo: la pendenza di una rampa, l’altezza di un lavabo, la difficoltà di aprire una porta pesante”. L’inclusività non è più un elemento posticcio, ma un principio fondativo che obbliga a ripensare radicalmente i processi di progettazione.
Architetture che si muovono
Esistono sperimentazioni radicali dove il movimento diventa principio generativo del progetto. Già alla fine degli anni Venti, l’ingegnere Angelo Invernizzi realizzava a Verona Villa Girasole, una straordinaria casa di villeggiatura rotante che si adatta al movimento solare – un esempio pionieristico di architettura che compensa l’immobilità dell’utente attraverso il movimento dell’edificio stesso. Qui il recente podcast dedicato.
Anche la rampa, pur nella sua apparente staticità, può configurarsi come dispositivo di movimento e adattabilità. Se pensiamo alle rampe di Le Corbusier – dalla Villa Savoye alla Casa per il medico Curutchet – vediamo come questo elemento diventi il percorso obbligato per fare esperienza dello spazio architettonico, una machine à habiter che anticipa involontariamente soluzioni oggi adottate per l’accessibilità.
Decenni dopo, la Maison à Bordeaux (1994-1998) di Rem Koolhaas, nell’immagine di copertina, realizzata per l’editore tetraplegico Jean-François Lemoine, sviluppa questo principio con una piattaforma mobile di 3×3,5 metri che scorre lungo un’intera parete-libreria, collegando i tre livelli della casa. Non si limita a compensare una condizione, ma la assume come occasione per esplorare nuovi dispositivi spaziali.
Anche la Sperone Westwater Gallery di Norman Foster integra una moving room che può arrestarsi ai diversi piani, ampliando temporaneamente le superfici espositive. Questi esempi mostrano come l’architettura possa diventare un corpo a sua volta: capace di adattarsi, muoversi, trasformarsi, esattamente come fanno i corpi che la abitano. Un progetto che accoglie movimento, asimmetria, imprevedibilità è un progetto che riconosce la varietà delle esistenze.
L’invisibilità come misura dell’efficacia
Il parallelismo con il restauro rivela un criterio di qualità fondamentale: come il miglior restauro è quello che non si vede ma risolve i problemi conservativi, così la migliore inclusività è quella che diventa invisibile, integrata nella qualità generale del progetto. Maria Chiara Ciaccheri lo documenta nei musei europei più avanzati, dove “le scelte per l’accessibilità risultano talmente integrate da essere invisibili”. Questa invisibilità dell’efficacia emerge anche dal contributo di Ubaldo Spina di Ponte Giulio, che sottolinea come “in Europa ci sia mediamente una maggiore attenzione all’impatto stilistico della soluzione, una riflessione sull’ambiente in generale” rispetto al pragmatismo americano. Il “bagno deve essere bello da vivere e bello da vedere”, sintesi perfetta di funzione ed estetica.
L’invisibilità diventa così strategia per superare il pregiudizio estetico che spesso accompagna gli ausili per l’accessibilità, una resistenza che impatta negativamente sul turismo accessibile quando gli albergatori evitano interventi nelle camere temendo di renderle meno appetibili agli utenti normali. È qui che soluzioni come i maniglioni rimovibili acquisiscono un valore che va oltre la funzione: quando non sono in uso, possono essere sganciati lasciando la parete libera e ordinata, con una copri-piastra che mantiene l’estetica dell’ambiente proteggendo l’ancoraggio. L’accessibilità non compromette il decoro, ma lo ridefinisce attraverso la qualità del progetto.
Politica e incertezza
L’inclusività architettonica non è questione tecnica ma politica. Maximiliano Ulivieri lo dimostra analizzando come l’overtourism diventi barriera per i residenti con disabilità, mentre Elena Granata denuncia l’ossessione per il decoro che “trasforma la città in un luogo di esclusione: […] se perdiamo questa urbanità, cosa rimarrà della nostra più autentica cultura civile? La vera questione allora non è architettonica o urbanistica, ma politica. Dobbiamo avere il coraggio di un autentico ribaltamento: trasformare i divieti in desideri, le negazioni in possibilità, le norme acquisite in ascolto”.
Henri Lefebvre aveva ragione: “Lo spazio dà ordini ai corpi; prescrive o vieta gesti e percorsi”. Ogni scelta progettuale – l’altezza di un bancone, la larghezza di un corridoio, la texture di un pavimento – definisce chi può agire e come. Il progetto diventa così redistribuzione delle possibilità d’azione nello spazio, pratica di cittadinanza attiva che riconosce nella diversità corporea non l’eccezione ma la ricchezza della condizione umana. Aimi Hamraie sottolinea come “dovremmo progettare per le persone più emarginate, indipendentemente dal fatto che ciò avvantaggi la maggioranza della popolazione”, criticando l’ideologia post-disabilità che ha depoliticizzato il tema. Parallelamente, l’esperienza sui beni monumentali dimostra che “l’accessibilità non è una deroga, né un’aggiunta tecnica. È un progetto culturale” che trova nei criteri del restauro – reversibilità, compatibilità, distinguibilità – strumenti metodologici ancora attuali.
La vera sfida è progettare per l’incertezza, per la diversità delle situazioni e dei corpi, per l’uso non normato. Un’architettura davvero inclusiva deve rinunciare all’illusione dell’utente medio, per aprirsi a ciò che è transitorio, instabile, mutevole. E proprio per questo l’inclusività rischia di rimanere un ideale irraggiungibile: ogni scelta implica un’esclusione, un compromesso. Ma è nell’accettazione di questa tensione che il progetto si fa politico: non perché risolve ogni bisogno, ma perché li riconosce e li mette in dialogo.
L’arte di spostare il baricentro
L’architettura inclusiva non è una tipologia, né un insieme di soluzioni tecniche. È piuttosto un atteggiamento, una postura critica nei confronti dello spazio e della società. È l’arte di spostare il baricentro del progetto: dai canoni consolidati alle esperienze reali, dai parametri normativi ai corpi vivi, dai luoghi della rappresentazione a quelli dell’uso quotidiano. Dalla formazione universitaria – dove, come sottolinea Valeria Tatano, “l’inclusività dovrebbe essere una competenza trasversale, come l’etica o la sostenibilità” – alla pratica professionale, la sfida è sviluppare una cultura architettonica che non smette mai di domandarsi chi resta fuori.
Da quale architettura possiamo allora apprendere? Non si tratta di cancellare l’eredità moderna quando è inaccessibile, quanto di valutarne caso per caso le possibilità di adeguamento senza snaturarne i valori, come già avviene per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico. Come evidenziano i memoriali analizzati da Anna Bernardi o i parchi giochi studiati da Adolfo Baratta, nonché negli interventi raccolti sul patrimonio monumentale, ogni progetto può diventare occasione per ripensare “l’architettura come forma di cittadinanza”. Bernardi dimostra come la memoria del trauma richieda spazi che sappiano accogliere la vulnerabilità, mentre Baratta evidenzia come il gioco necessiti di accessibilità che non comprometta la spontaneità: due facce della stessa sfida progettuale che riconosce nell’inclusività non solo un diritto, ma una qualità essenziale dello spazio pubblico.
Il compito dell’architettura contemporanea non è semplificare la complessità umana ma tradurla in spazio abitabile. Non eliminare le differenze ma renderle produttive. Se dovessimo reinterpretare il celebre aforisma di Ludwig Mies van der Rohe “less is more”, per l’architettura inclusiva potremmo dire: “less is not enough”.
Una rampa ben progettata, come ricordavamo di recente per l’accessibilità al patrimonio, “non è una corsia per pochi, ma un’altra possibilità di attraversare il mondo”. In questo attraversamento, l’architettura smette di essere barriera e torna ad essere ciò che dovrebbe sempre essere: apertura.
Immagine copertina: Rem Koolhaas, Maison à Bordeaux (1994-1998)
![]()
Giancarlo De Carlo, Casa Ceccarelli, Bologna, 1961-62
Francesco Ceccarelli, “A House in the Form of a City. Casa Ceccarelli in Bologna (1962-63)”, “Histories of Postwar Architecture”, “Giancarlo De Carlo at 100” (1919-2019), No. 5 (2019), pp. 49-63.
https://censimentoarchitetturecontemporanee.cultura.gov.it/scheda-opera?id=838
Michael Graves
https://www.nytimes.com/2003/06/12/garden/an-architect-s-world-turned-upside-down.html
https://georgevanantwerp.com/2012/06/22/interview-with-michael-graves-on-healthcare-design/
https://www.ilpost.it/2014/07/16/michael-graves-architetto-disabili/
https://www.arts.gov/stories/blog/2019/flashbackfriday-legacy-designer-michael-graves
Rem Koolhaas-OMA, Maison à Bordeaux
https://www.oma.com/projects/maison-a-bordeaux
Norman Foster, Sperone Westwater Gallery
https://www.fosterandpartners.com/projects/sperone-westwater
https://divisare.com/projects/142515-foster-partners-sperone-westwater-gallery
Architetto e docente di Storia dell’Architettura e di Restauro presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio, Università della Svizzera Italiana. Affianca la ricerca storico-scientifica alla pratica professionale, integrando la progettazione con un aggiornamento continuo su tecnologie e materiali di ultima generazione.
Da oltre vent’anni
Studio Bettini Architetti
Associati si occupa di
restauro monumentale, riuso del costruito, allestimento degli interni.
Opera su commissioni
pubbliche e private nei contesti storici più delicati. Propone un approccio innovativo al design inclusivo
per sviluppare soluzioni progettuali che integrino accessibilità e inclusività, rispettando e valorizzando il patrimonio esistente.